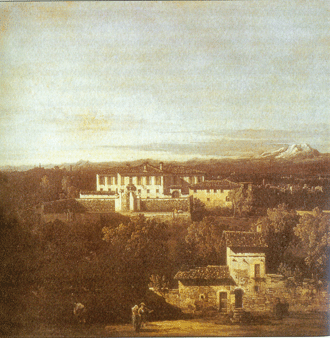|
Anno 4 - N. 11/ 2005
Lettura storiografica
La Veduta dalla Gazzada del Bellotto
Da un’alzata della villa perablò, ottenne il portento della prospettiva paesistica senza tradire la riuscita poetica dell’arte: anzi, proprio in quella veduta trovò, per la prima volta, un’originalità di sé stesso nel segno di una luce solo “sua”…
di Luigi Zanzi
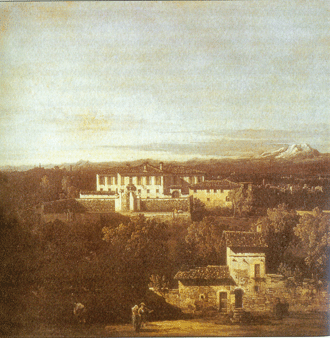
Se si riconosce un margine d’intuizione approssimata entro il quale si giustifichi l’attribuzione di un tempo “proprio” a una certa “natura locale”, allora pochi casi riusciranno in ciò così azzeccati come se per il paesaggio di Varese si fisserà l’età della più felice occasione, cioè l’età più “sua”, in un congruo periodo che si situa in pieno 700.
Fuor di pedanteria, quando si limiti in confini precisi il significato allusivo di questo uso spontaneo di riconoscere una stagione di civiltà come più rispondente di altre alle latenti virtù naturali di un certo luogo, si potrà pur dire che i valori paesistici di questi luoghi del “Varesotto” ci si consegnano più schiettamente intesi da quella cultura che, prevenendo dal “barocco”, si disponeva variamente a molteplici esiti “illuministici”. Riesce quindi pertinente insistere che questo nei dintorni di Varese, preso a colpo d’occhio, o a volo d’uccello, è uno dei paesaggi ”barocchi” più belli che ci siano: con le colline amene, l’andamento “manieristico” dei pendii fino al lago, le piccole selve bucoliche, lo scenario delle Alpi, sul fondo, distante quanto basta per sorprendere senza intimorire.
S’impone a prima vista per chi viene da Milano, lungo la pianura tortuosa che si dispiega in “terrazzi alti”, in una giornata serena, la complessa valenza paesistica dello scenario inconfondibile di questa terra; dove, come osservava nel 1739 il Presidente de Brosses, qui girovago curioso, “si cominciano a sentire le radici delle Alpi”, e dove appena alle spalle delle rive dei laghi “le montagne tutte ricoperte di neve rinfrescano la vista”, dove le colline s’aggiogano in scherzi rupestri e le impreviste impennate montuose di qualche “poncione “conico che però termina in tondeggianti erte di prato, con poche rughe di roccia assaltata dai faggeti e dalle roverelle; dove la grande conca morenica in cui s’affossa lo sbocco delle valli, ospita un lago frastagliatissimo di insenature, ora melmoso e grasso, ma in altri tempi ricco d’acque schiette e pescosissime; dove le discendenze ondulate dei monti consentono riviere campestri nel susseguirsi delle balze coltivate ad orto e, un tempo, a vigneto; dove è quasi inevitabile riscontrare il tratto esclamativo del giro d’orizzonte sulla scena dello scorcio ameno, della vista a sorpresa, ancor più mirabile quando qualche lembo di nebbia tra le torbe, le paludi e i canneti , acuisce la prospettiva delle campagne che si susseguono verso lo sfondo del Monte Rosa.
È una visione variamente allietata da tutti gli elementari requisiti di un ideale di Naturache, qualche anno appena dopo la metà del ’700, il Parini delle Odi avrebbe a guidare man mano fuori dell’Arcadia, rinnovando l’eco d’Orazio e del “marchettiano” Lucrezio: ravvivata però dai recenti ardori mitici ragionati da Rousseau, e sapientemente calibrata in un “utile e lusinghevol cant”; efficace ed elegante “moralized song” in cui è lucidamente ritmata l’espressione di un sensismo “toccante”, strumento di fervidi intenti didascalici.
Si ricordi a commento di questa immagine di paesaggio, qualche terzina della Vita campestre (che risale a prima del ’758) ove si esalta che “…all’alma ingenua, all’incorrotta mente,/la spontanea natura offre sé stessa/d’infinito piacer viva sorgente”: nonché della Vita rustica (composta tra il ’756 e il ’757) o de La salubrità dell’aria (forse del ’759) ove si cantavano i “colli beati e placidi/che il vago Eupili mio/cingete con dolcissimo/insensibil pendio ”ve si oggettivano nitide le “belle colline”, il “bel lago”, il “bel paese alta di monti schiena”. Si aggiunga soltanto lo sfondo magnificante del cerchio dei ghiacciai lontani, che sostiene qui, in fronte a Varese, una distesa assai più ampia, mossa e “barocca”, che non fosse il sito più dolcemente ondulato, ritirato e “arcadico” della Brianza e del lago di Pusiano.
Senonchè è subito da togliere l’illusione che tale rispondenza sia frutto esclusivo di “naturale” predisposizione per due inequivocabili ragioni: primo, perché essa è frutto di una cifra paesistica tramandataci in maniera colta, quale modello di una abitudine di vedere “realistica” fin che si vuole, ma costruita apposta per conformità a un paradigma di civilizzazione (anche del Paesaggio); secondo, di fatto, essa è frutto di un’apposita strutturazione che di questi luoghi si è fatta appunto nel ’700, quando di tale ambiente si sono apprezzati taluni valori, predisponendo opere atte a goderli e conservarli, traducendo, fra l’altro, in esso, una gerarchia di rapporti tra “civiltà di villa” e risanamento della “villa rurale” che per lungo tempo è resistita.
Per farne la prova, si prenda la mira del Bellotto, dalla “Gaggiada”: di lì; donde egli si affacciò nel 1744 per confezionare, quasi certamente con l’aiuto di una “cassa optica”, una veduta che riuscisse esatta per essere apprezzata allora da committenti di gusto decisamente “illuminata” (forse, nel caso, uno dei Melzi d’Eril od un Simonetta, ma è da tener conto che l’ Adamollo attribuisce la villa, ancora del ’745, a Giuseppe e Gabrio Fratelli Perabò, rispettivamente “Sindaco Generale e Secretario della città di Milano”).
Erano, tali vedute, conformi agli usi della pittura “scientifica”, la quale urgeva allora a scomodare dai salotti di Londra, come da quelli di Venezia o di Parigi, le composizioni di “bella natura”, per immettervi, con annunzi rivoluzionari, quadri “veridici”, risultati di un’ambientazione naturale registrata con parametri quasi topografici.
L’entusiasmo per tali dipinti panoramici s’ispirava ad un “naturalismo” instancabilmente controllato in chiave “realistica”; che era, peraltro sull’orlo sempre d’inaridirsi, quando fosse immemore di quanta poesia occorre per interpretare, pur servendosi di accorti potenziamenti tecnici, quell’idea di verità che, già sul finire del ’500, sull’orlo precipite del manierismo, era stata la ribelle “scoperta“ del Caravaggio.
Quell’idea stessa di una “pittura verità” s’era poi fatta paradigmatica, anche in ossequio al precetto “tridentino” trionfante nel primo ’600, di dipingere “secundum veritatem”; e così si era poi isterilita, salvo poche eccezioni; ma più tardi s’era riaccesa di nuova vitalità, con una lucidità e un nitore del tutto inimmaginati prima d’allora, sotto la spinta di quella passione quasi “scientifica”, di cui poi l’enciclopedista Diderot si farà interprete, almeno dal ’755 in poi, nell’esercizio della critica pittorica, secondo canoni di perfetta rispondenza tra ciò che è “naturale” e ciò che è “razionale”. Valendosi dunque di quell’ordigno (che l’Algarotti, già nel Newtonianismo per le dame de ’737, aveva lodato quale miracoloso “occhio artificiale”, ponendolo quale strumento dei pittori, in parallelo al cannocchiale degli astronomi e al microscopio dei fisici: variante di congegni portatili usati frequentemente dagli ottici, come già dal celebre Keplero) il Bellotto, allora, da un’alzata della Villa Perablò, ottenne il portento di quella prospettiva paesistica senza tradire la riuscita poetica dell’arte: anzi, proprio in quella veduta trovò, per la prima volta, un’originalità di sé stesso. Ciò avvenne nel segno di una luce solo “sua”, tutta vitrea, fredda, provocatrice di allungati filamenti d’ombra, fissamente intonata ai velami trasparenti dei meriggi di un autunno appena iniziato; riflesso uniforme di una serenità costante, più climatica che tangibile; uno spessore d’aria che brunisce il fogliame folto e vi annida orlature baluginanti di un chiarore argenteo che non sa più di sfavillii d’altare, ma esprime una sorta di germinazione lattiginosa tra le chiome rosate degli alberi, tra le verzure dei cespugli olivastri. Quella luce simbolica, “che s’apprende alle cose, come materia su materia”, che è tutta terrestre, riesce a far intuire ed esaltare “ritrattisticamente” un valore paesistico nuovo, in questo scenario, quasi mostrando un mutamento di rotta nella prospettiva panoramica. Quella luce indaga e rivela un percorso tracciato nella realtà appositamente per far risultare un rapporto diverso, appena scoperto, tra la società umana e la natura. Si ispezioni dunque, nella veduta dalla Gazzada, il defilarsi accorto delle quinte ricciute delle fronde del frutteto circoscritto alla villa, la quale vien colta da un punto di vista rialzato, immaginario ma artificialmente costruito con misurata precisione; si percorra il giro della strada che s’allarga sulle terrazze campestri; si segua l’orlo zigzagante dello scorcio lacustre, frastagliato da varie insenature che si stagliano verso lo sfondo, fino a scoprire in lontananza l’intreccio ondulato degli speroni collinari che piegano e sommuovono come vertebre il cerchio delle Prealpi; si esplori quella sfilata di monti-dromedari, dietro i quali emerge alta, fino a sembrare un corpo-quasi-nuvola, la mole del colosso ghiacciato, a cui traguarda la vista da ogni parte delle terre del Ticino si proietti da est verso nord; il Monte Rosa.
Poi, per controprova, si torni a riscontrare la villa, le sue pareti intrise di luce lattea, i muri dell’orto, qua e là scalcinati, il carro che passa tirato dai buoi che s’allungano e oscillano, bianchissimi; la testa e la schiena di un agricoltore che scende di là da una ripa campestre e così ogni altra cosa che Bellotto ha posto sotto quell’enorme, luminoso cielo.
Alla fine di questo esame una conclusione si impone: è qui anticipata in immagine una civiltà della natura che non è più una fuga della realtà, ma intuisce un rapporto preciso d’ambiente tra la villa aristocratica, il territorio rurale, e lo stesso spettacolo del lago e dei monti. È un paesaggio ancora “barocco”: ma con una sfumatura decisamente diversa che occorre intendere […]
Si è fuori, qui, ormai dai miti d’Arcadia, dal realismo “esemplare”; si è lontani dalle “cose finte di cui è madre l’idea”, delle quali il Gravina aveva regola della “ragion poetica”; né s’indulge sulla “novità”, né sulla “meraviglia. Nulla è qui costruito in vista di una scena immaginaria. Se uno si mette, d’impegno, a controllare questa veduta del Bellotto, riconoscerà che finanche tra lo sfondo delle montagne, che pur avrebbe potuto essere approssimato in obbedienza a questioni del “buon gusto”, si trova quasi un accentramento topografico, quasi una mappa a rilievo ù: così, pochi anni prima che Horace-Bénédict de Saussurre “filosofo naturale” dell’Accademia di Ginevra, porti l’esplorazione del “lumi” su quelle cime ancora temute dalla superstizione locale, il Bellotto sta fedele a ciò che vede con l’aiuto della sua “cassa-optica” e profila già con esattezza, a fianco del Monte Rosa, l’intiera catena risplendente delle vette di Jazzi, dei Fillar, del Jägerhorn e, più in là, dello Stralhorn, dei Mischabel ecc.; tutte perfettamente riconoscibili.
Nulla è frutto di convenzione, di modello: il realismo si fa naturalistico.
da Segni del ’ 700 in Varese, 1981

|