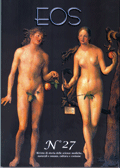|
Anno 9 - N. 25/ 2010
«Un’idea di uomo come modello di natura umana»
L’ATTUALITÀ DI SPINOZA
Spinoza ha dato luogo alla più grande rivoluzione filosofica di tutti i tempi, ma questa rivoluzione è stata negata, cancellata, combattuta, condannata, rimossa [...]
Lo spettro dello spinozismo si manifesta, sotterraneo e multiforme, in tutta Europa ed in tutta Europa è perseguitato dalle autorità politiche e religiose attraverso il rogo dei libri, l’esilio, la prigione.
di Vittorio Morfino

Baruch Spinoza (Amsterdam, 1632 - L'Aia, 1677)
Che cos’è la filosofia? Non è facile farsene un’idea nella società contemporanea se si prendono in considerazioni le apparizioni di sedicenti filosofi sui media di massa, i festival o la nuova moda del counseling, ma non è nemmeno facile farsene un’idea dai manuali che abbiamo studiato al liceo, sorta di cimitero di elefanti a somma zero.
Non è facile perché ciò che è cancellato o rimosso è la dimensione fondamentale della filosofia, la dimensione politica, quella dimensione per cui Socrate si diede la morte, in ottemperanza alle leggi della città di Atene che aveva poste in questione con il suo domandare. Kant diceva che la filosofia è un Kampfplatz, un campo di battaglia, a cui credeva di poter imporre la pace perpetua del criticismo. Ma ogni pace perpetua è un miraggio, poiché il conflitto filosofico, lungi dall’aver luogo nello spazio etereo della pura teoria, ha luogo nella polis, nella città, e dei conflitti sociali, politici e religiosi della città è allo stesso tempo sintomo e rielaborazione. Di questa natura conflittuale della filosofia Spinoza è un esempio paradigmatico. Spinoza pensò nel conflitto ed il conflitto determinò la sua vita ancor prima della sua nascita. La persecuzione degli ebrei in Spagna e Portogallo costrinse la sua famiglia a rifugiarsi nella libera ed accogliente Amsterdam, dove si formò un’importante comunità ebraica. Il giovane Spinoza studiò nella sinagoga di Amsterdam e qui cominciò a pagare il prezzo della libera filosofia: contro di lui fu pronunciata una terribile scomunica, herem, che lo escluse dalla comunità in cui era cresciuto. Ma non basta. Il Trattato teologico-politico, l’unico dei suoi capolavori che pubblicò in vita (pur senza il proprio nome in copertina e con luogo di edizione falso), fu condannato dalle Supreme Corti della libera Olanda, tanto che egli decise di non pubblicare l’Etica, uno dei capolavori supremi della filosofia Occidentale. Ma qui, finita la vita, comincia la storia dello spettro dello spinozismo, che si manifesta, sotterraneo e multiforme, in tutta Europa ed in tutta Europa è perseguitato dalle autorità politiche e religiose attraverso il rogo dei libri, l’esilio, la prigione. Una storia che si prolunga fino ai giorni nostri, perché dovunque si combatta per la libertà e contro l’oppressione e la superstizione il nome di Spinoza riemerge indomito.
Louis Althusser, probabilmente il più importante pensatore marxista del XX secolo, ha scritto che Spinoza ha dato luogo «alla più grande rivoluzione filosofica di tutti i tempi», ma che questa rivoluzione è stata negata, cancellata, combattuta, condannata, rimossa e forse per questo la filosofia di Spinoza non cessa di ripresentarsi sotto sembianze multiformi e spettrali in ogni epoca: come il fantasma del padre di Amleto torna perché non sia dimenticata la colpa del suo assassino, così il fantasma dello spinozismo ritorna sotto varie forme a ricordare la colpa di quella grande rivoluzione cancellata e rimossa.
Ma in cosa consiste la rivoluzione filosofica spinoziana? Si tratta della radicale negazione di ogni forma di trascendenza, della negazione di quel mondo soprasensibile che ha dominato la tradizione filosofica Occidentale con il nome di metafisica. Non è un caso che proprio riferendosi alla tradizione greca, Spinoza avesse respinto con forza l’autorità di Aristotele e di Platone e si fosse dichiarato allievo di Democrito, Epicuro e Lucrezio, e non è un caso nemmeno che il solo autore che egli cita in termini elogiativi nelle sue opere politiche sia Machiavelli: il riferimento chiaro è ad una tradizione sotterranea, materialista, antimetafisica. Una tradizione combattuta e sommersa.
Come è noto, la forma espositiva dell’Etica è geometrica. La prima parte è dedicata a Dio e questo non tragga in inganno: come scrive Althusser, Spinoza, «supremo stratega, cominciava con l’investire la suprema piazzaforte del suo avversario, o piuttosto vi si installava come se egli fosse il suo stesso avversario, dunque non sospetto d’esserne l’avversario giurato, e ne ridisponeva la fortezza teorica in modo da rivolgerla completamente, come si rivolgono dei cannoni contro i suoi stessi occupanti». Fuor di metafora, Spinoza smonta, attraverso la rete concettuale dell’apparato dimostrativo, le concezioni tradizionali che si incarnano tanto nelle filosofie precedenti quanto nei pregiudizi religiosi. Spinoza comincia da Dio e, nel costruire passo passo lungo le 36 proposizioni della prima parte dell’Etica, il suo concetto razionale, rende allo stesso tempo impensabile il Dio della tradizione, libero creatore dell’universo, la cui superstizione è alimentata dalla naturale disposizione degli uomini a considerarsi centro e fine della natura. Spinoza rifiuta ogni concezione teologica e metafisica che ponga l’intelletto e la volontà divina (indipendentemente dal primato dell’una o dell’altra) all’origine del mondo: tutto ciò che Dio produce deriva per necessità dalla sua natura senza che questa implichi uno scopo; in principio non è il logos, ma l’azione, la potenza infinita in cui solo consiste l’essenza di Dio.
Il perno di tutta la prima parte è costituita dalla proposizione 18 in cui Dio è definito causa immanente e non transeunte di tutte le cose, a cui Spinoza giunge dopo aver dimostrato che Dio ovvero la sostanza infinita esiste necessariamente, è indivisibile, unico e agisce per le sole leggi della sua natura, cioè è causa libera. Costruito il concetto razionale di Dio, Spinoza passa a definire il rapporto tra Dio e il mondo, le cui manifestazioni singolari egli chiama “modi”: il mondo è l’effetto dell’azione produttrice di Dio, che in quanto causa immanente, nel produrre il mondo autoproduce se stesso. Dio è causa tanto delle essenze quanto delle esistenze dei modi, ossia l’essenza e l’esistenza di ogni modo è pensabile solo in relazione all’attività produttiva della totalità infinita, che tuttavia essendo immanente si dà a vedere solo come connessione di modi.
Con ciò Spinoza afferma la natura relazionale di ogni individuo, che dunque non può sussistere in sé come nella tradizione aristotelica o nella tradizione individualistica moderna, ma è un intreccio di relazioni, un composto dinamico in cui non esiste separazione netta tra interno ed esterno, ma i cui termini si costituiscono, in modo sempre provvisorio, nella relazione stessa.
In questo contesto che cosa ne è dell’anima? Per comprendere la teoria spinoziana della mente (il termine “anima” sparisce progressivamente nel suo lessico), si deve prendere in considerazione il luogo filosofico da cui essa a un tempo prende le mosse e si distanzia definitivamente: si tratta della teoria cartesiana dell’errore. L’errore per Descartes dipende dal concorso di due cause, dalla facoltà di conoscere e dalla facoltà di scegliere, cioè dall’intelletto e dalla volontà. L’intelletto è definito da Descartes come la facoltà di concepire le idee delle cose, la volontà come la facoltà di affermare e negare queste stesse idee. Ora la volontà, a differenza dell’intelletto che è limitato, è amplissima e perfetta nel suo genere: proprio questa caratteristica della volontà testimonia della rassomiglianza dell’uomo con Dio. Infatti la volontà di Dio benché sia incomparabilmente più grande della volontà umana in ragione della conoscenza e della potenza, come in ragione dell’oggetto, non lo è dal punto di vista formale, poiché entrambe consistono nella possibilità di affermare e di negare. L’uomo è dunque dotato di un intelletto limitato che è la luce in grado di illuminare le idee (che sono “quadri” o “immagini” delle cose) e di una volontà che afferma e nega queste idee: l’errore consiste dunque nello spingere la volontà oltre i limiti dell’intelletto, cioè nel voler affermare o negare ciò che non sono in grado di rappresentare in modo chiaro e distinto.
Spinoza smonta dal suo interno il concetto di mente cartesiano. In primo luogo, dalla teoria dell’unica sostanza segue necessariamente che l’uomo essendo un modo singolare non può avere la forma della sostanza. In secondo luogo Spinoza afferma che intelletto e volontà non esistono come facoltà, ma sono semplicemente degli esseri di ragione, dei termini universali attraverso cui noi riuniamo le cose singolari: «nella Mente», scrive Spinoza, «non si dà alcuna facoltà assoluta di intendere, di desiderare, di amare, ecc. Donde segue che queste e simili facoltà o sono del tutto fittizie, o non sono altro che enti Metafisici, ossia universali che siamo soliti formare dai particolari. Così che l’intelletto e la volontà stanno a questa e quella idea o a questa e quella volizione nello stesso modo in cui la petreità sta a questa e quella pietra o in cui l’uomo sta a Pietro o Paolo». La volontà e l’intelletto non sono che enti di ragione; non esistono in realtà che singole volizioni e singole intellezioni.
Tuttavia Spinoza si spinge oltre. Egli rifiuta il concetto cartesiano di idea intesa come «muta pittura su un quadro», che deve essere affermata o negata dalla volontà, producendo così un giudizio: l’idea è per Spinoza l’attività stessa del conoscere, per cui nella mente non si dà alcuna volizione, ossia affermazione o negazione oltre quella che l’idea, in quanto idea, implica. Da ciò segue che la volontà e l’intelletto sono una sola e stessa cosa. Non esistono dunque più i quattro elementi della teoria cartesiana, cioè la mente (la res cogitans), la facoltà intellettiva, la facoltà volitiva e le idee, ma un solo elemento radicalmente nuovo, ossia l’idea come potenza produttiva. Resta infine da risolvere il problema dell’errore all’interno di questo nuovo quadro teorico: l’errore cioè non può essere l’effetto dell’applicazione della volontà al di fuori dei limiti dell’intelletto, ma è l’effetto necessario della struttura del nostro corpo e delle suo relazioni necessarie con l’ambiente circostante. Il rapporto tra idea ed errore (ossia immaginazione) non è dunque da pensarsi nei termini di una disgiunzione: l’idea vera non toglie l’immaginazione, ma ne spiega la genealogia necessaria e le ragioni della sua efficacia (la concezione copernicana spiega il movimento apparente del sole, ma non ne cancella la percezione). Date tali premesse allora il rapporto tra immaginazioni e idee va pensato come un rapporto di forze tra affetti: «il desiderio», scrive infatti Spinoza, «che nasce dalla vera conoscenza del bene e del male, può essere estinta e ostacolata da molte altri desideri che nascono dagli affetti dai quali siamo combattuti».
La mente in Spinoza non ha dunque la forma della sostanza ma piuttosto di un rapporto di forza tra idee, che hanno come oggetto il corpo e le relazione che esso intrattiene con l’ambiente circostante. E proprio nel concepire il rapporto tra la mente ed il corpo Spinoza sovverte la teoria classica del rapporto anima-corpo secondo cui quando l’anima agisce il corpo patisce e viceversa: in Spinoza il potenziamento della mente e del corpo sono simmetrici e consistono nella ricerca costante della gioia. Tuttavia, finché l’uomo immagina, tanto il potenziamento che il depotenziamento sono del tutto accidentali (sono l’effetto cioè dell’ordine “fortuito” dell’esperienza umana): gli uomini sono «agitati dalle cause esterne in molti modi e […], come le onde del mare, agitate dai venti contrarii, fluttua[no], inconsapevoli della [propria] sorte e del destino». Anche la gioia e il desiderio sono affetti passivi tanto quanto la tristezza, ossia sono prodotti dall’intreccio della necessità. Vi sono però, oltre a questo tipo di gioia e di desiderio, un altro tipo che si riferisce a noi in quanto siamo attivi: in quanto siamo in grado di formare delle idee adeguate delle cose, possiamo elaborare una risposta alle sollecitazioni dell’ambiente fondata sulla conoscenza razionale che possiamo averne.
Su questa base, nella quarta parte dell’Etica, Spinoza forma «un’idea di uomo come modello di natura umana», la cui virtù (che Spinoza identifica con la potenza) lo renda capace di opporsi al fortuito fluttuare delle cause esterne. Tuttavia per quanto un uomo accresca la sua potenza non potrà mai affrancarsi dalla natura, poiché come recita l’unico assioma della quarta parte, «in natura non esiste alcuna cosa singolare della quale non ne esista un’altra più potente e più forte […] dalla quale può essere distrutta». In altre parole in quanto l’uomo è parte della natura egli sarà sempre e necessariamente soggetto alle passioni. Si tratterà dunque, per realizzare l’exemplar humanæ naturæ, non di dominare le passioni attraverso la ragione come in Descartes, bensì di utilizzare in modo strategico la ragione stessa come una passione tra le altre: «agire in assoluto secondo virtù non è altro che agire, vivere e conservare il proprio essere secondo la guida della ragione (queste tre cose significano lo stesso), e questo in base al principio della ricerca del proprio utile».
La virtù spinoziana è radicalmente anticristiana, è un rifiuto della virtù come ripiegamento dell’uomo nell’interiorità della propria coscienza, dei valori ascetici, del pentimento e dell’umiltà (che sono forme di tristezza), dell’esaltazione della melanconia e dell’isolamento tipica negli autori barocchi spagnoli, dell’idea platonico-cristiana della vita come esercizio di morte. L’uomo si potenzia vivendo nel mondo, attraverso le molteplici esperienze del mondo, e tanto più il suo corpo entra in relazione con le cose esterne tanto più la sua mente conosce e diventa virtuosa: per questa ragione, come scrive Spinoza nella proposizione che conclude la parte V, «la felicità non è il premio della virtù, ma la virtù stessa», in altre parole la felicità non è il premio ultraterreno di chi si è ritratto dal mondo, ma essa si dà nella molteplicità delle relazioni che l’uomo intrattiene con la natura e con gli altri.
Veniamo brevemente alla teoria politica che Spinoza elaborò in due opere distinte, il Trattato teologico-politico, che egli scrisse tra il 1665 e il 1670, e il Trattato politico, la cui stesura, iniziata nel 1675, fu interrotta dalla morte nel 1677. Nel capitolo XVI del Trattato teologico-politico Spinoza vi espone i cardini della sua teoria, riprendendo, almeno su un piano terminologico, le problematiche giusnaturalistiche in generale e in particolare il De cive di Hobbes. Spinoza pensa alla società come il risultato di un patto: «gli uomini […] per vivere in sicurezza e nel miglior modo, dovettero necessariamente unirsi e far sì da avere collettivamente il diritto che ciascuno per natura aveva su tutte le cose e che questo fosse determinato, non più dalla forza e dall’istinto di ciascuno, ma dal potere e dalla volontà». Tuttavia, mentre in Hobbes nel patto ogni uomo aliena una volta per sempre il suo diritto naturale a favore del sovrano, in Spinoza il patto sussiste solo fintanto che dura la sua utilità e viene meno con essa. Questa concezione radicalmente innovativa del patto che dà origine la società si fonda su una concezione del diritto naturale individuale del tutto differente da quella giusnaturalistica. Il diritto naturale infatti non è un valore tipicamente umano e razionale che deve essere riconosciuto e difeso dallo Stato, ma è la regola di funzionamento di ogni individuo della natura: ogni individuo ha tanto di diritto ad esistere e ad agire quanto ha di potenza, «così, per esempio, i pesci sono dalla natura determinati a nuotare e i grandi a mangiare i più piccoli, onde […] di pieno diritto naturale i pesci sono padroni dell’acqua e i grandi mangiano i più piccoli». In un contesto di tal genere lo Stato non può che essere il risultato di un accordo basato su un calcolo di vantaggi e di svantaggi, a cui ogni uomo può sottrarsi nel momento in cui vengano meno le ragioni del patto. Tra lo stato di natura e lo stato politico non vi è dunque una cesura netta, non vi è reale opposizione tra naturalità e artificio, ma il primo si prolunga nel secondo senza venire mai meno. Se dunque il potere sovrano non è soggetto ad alcuna legge (cioè è legibus solutus, come il Leviatano hobbesiano), tuttavia se vuole mantenere il proprio potere dovrà agire secondo ragione e dunque per il bene comune; in caso contrario verrebbero infatti meno le condizioni che hanno dato luogo al patto. Per questa ragione Spinoza afferma che il potere democratico è la forma politica più naturale, poiché è difficile che la maggioranza cada in un assurdo che toglierebbe le condizioni del patto.
Nel Trattato politico, scritto subito dopo aver portato a termine la stesura definitiva dell’Etica, la problematica giusnaturalistica è del tutto abbandonata. Lo Stato non è più fondato sull’effetto incrociato di un calcolo individuale, bensì sulla potenza della multitudo: gli individui infatti non scelgono di prendere parte alla società, ma sono da sempre inseriti nella rete di passioni, di abitudini e costumi, che costituisce la struttura sociale umana. In questo orizzonte teorico non si tratta allora di creare un modello di Stato conforme alla ragione, ma piuttosto prendere atto della realtà effettuale della rete di passioni che attraversa la società per costruire delle strutture politiche in grado di bilanciarne gli effetti. Spinoza propone, negli ultimi capitoli del Trattato politico, alcuni modelli politici: la monarchia, che ha come riferimento storico negativo la monarchia turca; l’aristocrazia semplice, che ricalca l’esperienza veneziana; l’aristocrazia federale, che prende spunto dalle Province Unite; e la democrazia, che Spinoza definisce come la forma di potere «del tutto assoluta» prima che la morte ne interrompesse la trattazione. A prescindere tuttavia dalla forma di potere ciò che è decisivo è il fatto che questo potere si fondi in ogni caso sulla potenza della multitudo e che senza di essa non sia niente più che un guscio vuoto. Per questa ragione ogni potere sarà tanto più duraturo, quanto le sue istituzioni saranno in grado di trasporre sul piano politico le istanze della multitudo; in altre parole, ogni potere sarà tanto più duraturo quanto più sarà in grado di democratizzare le proprie istituzioni.
Infine il metodo di interpretazione della Sacra Scrittura, che costituisce una vera e propria gemma incastonata nel Trattato teologico-politico (capitolo VII), avrebbe come suo presupposto la critica dell’immagine tradizionale della divinità. Da questa critica segue necessariamente che Dio non può essere inteso in modo antropomorfo come l’autore del Testo Sacro nel quale egli ha comunicato la verità prima al solo popolo ebraico (Antico Testamento) e poi a tutto il genere umano (Nuovo Testamento). La Sacra Scrittura non è opera divina, ma umana, e come tale deve essere studiata: Spinoza dunque, fornendo al lettore il metodo di interpretazione della Scrittura, costruisce in realtà un metodo interpretativo di ogni libro che non si fondi sulle verità apodittiche della ragione. Per interpretare il senso della Scrittura è necessario ricostruire la sua storia:
1) in primo luogo è necessario ricostruire una storia della lingua nei quali questi libri furono scritti, cioè una storia della lingua ebraica (utile anche per comprendere la struttura ebraizzante del greco del Nuovo Testamento), in modo da «esaminare tutti i sensi di cui ciascun discorso è suscettibile secondo il comune modo di parlare»;
2) in secondo luogo gli enunciati di ciascun libro devono essere raccolti al fine di confrontare quelli che hanno il medesimo argomento, non trascurando di rilevare eventuali ambiguità, oscurità o contraddizioni;
3) infine si deve ricostruire a proposito dei libri profetici le notizie sui costumi, la cultura dell’autore così come l’occasione, i destinatari e la lingua in cui sono stati scritti; di tutti i libri invece si deve analizzare le modalità con cui sono stati tramandati, «come [ciascun libro] sia stato accolto in principio, in quali mani sia caduto e quante siano state le sue varie lezioni, quale concilio ne abbia decretato l’ammissione tra i libri Sacri, e infine come siano stati raccolti in un unico corpo tutti i libri universalmente riconosciuti per sacri». Il rifiuto spinoziano del Dio-autore del Libro porta dunque a un metodo di interpretazione che si occupa non della Verità di esso, ma delle molteplici pieghe del suo senso (per nulla unitario, ma pieno di ambiguità, oscurità e contraddizioni) e della storia materiale che ha condotto la Sacra Scrittura a presentarsi sulla scena del mondo come parola di Dio.
Il metodo di interpretazione della scrittura spinoziano presuppone un’idea di tradizione differente sia da quella farisaica, secondo cui essa avrebbe ricevuto «la certa tradizione e la vera spiegazione» dai profeti stessi, sia da quella cattolica, secondo cui «il pontefice non può sbagliare nell’interpretazione della Scrittura». Spinoza ritiene che si debba supporre la continuità di una tradizione, quella «del significato delle parole della lingua ebraica»: nessuno infatti ha mai «potuto trarre giovamento dal mutare il significato delle parole, non di rado invece dal mutare il senso del discorso». Dunque Spinoza rifiuta tanto l’idea di tradizione fondata sulla continuità della trasmissione della verità quanto quella fondata sull’autorità del capo della chiesa, poiché entrambe hanno interesse a modificare il significato della scrittura a scopo politico, ossia per rafforzare il proprio potere; fondare invece il metodo di interpretazione sulla continuità del significato delle parole, significa fondarlo su un aspetto non controllabile politicamente, poiché «a conservare la lingua concorre con i dotti anche il popolo». Tuttavia questa continuità è materiale, ossia si fonda sull’esistenza di una comunità politica che la conserva all’interno del proprio agire comunicativo: le calamità naturali e politiche che hanno colpito il popolo ebraico hanno quasi completamente distrutto la continuità di questa tradizione rendendo di fatto impossibile accedere al significato di molti passaggi della Scrittura
Una volta mostrato che la Scrittura non è la verità di Dio comunicata agli uomini, ma un libro che deve essere interpretato attraverso la ricostruzione della sua genesi e della sua struttura, si tratta di comprenderne l’utilità che esso ebbe storicamente per il popolo ebraico: il pentateuco (che gli ebrei chiamano Torah, legge) ha una funzione politica, ha costituito l’ordinamento politico della società ebraica, e i riti che esso prescrive impongono al popolo una costante obbedienza alla legge divina in ogni atto della vita. La Scrittura ha dunque come suo fine non di insegnare la verità ma di indurre l’obbedienza, il cui nucleo essenziale, al di là delle speculazioni teologiche sulla natura di Dio, si può ridurre al comando pratico di obbedire a Dio e di amare il prossimo. Attraverso il discorso sulla Sacra Scrittura Spinoza afferma dunque l’importanza del ruolo politico della religione per il mantenimento di un determinato ordine sociale. In particolare la religione è utile nei regimi monarchici per ammantare di sacralità la figura del re, in modo da indurre i sudditi «a combattere per la propria schiavitù come se fosse per la propria salvezza e da far loro credere che, non solo sia sconveniente, ma che sia il massimo degli onori il sacrificare il proprio sangue e la propria vita per la gloria di un solo uomo».
È stato detto che se una rivoluzione merita di essere definita copernicana, è senza dubbio quella spinoziana assai più di quella kantiana (piuttosto una sorta di controrivoluzione tolemaica). Ed è forse per questo che il fantasma di Spinoza non smette di abitare i nostri tempi: è un sintomo della nostra incapacità di pensare fino in fondo le conseguenze di questa straordinaria rivoluzione.

|