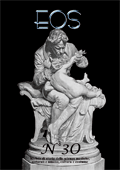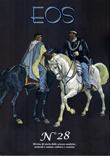|
Anno 10 - N. 30/ 2011
[...] ne I Battellieri del Volga ci restituisce l’agghiacciante atmosfera dei condannati ai lavori forzati. Simbolo di forza impotente, di dignità schiacciata.
PICCOLA PASSEGGIATA BALTICA
TRA STORIA & ARTE
“E’ mio soltanto il paese che porto
nell’anima.
C’entro senza passaporto, come in casa.
Lui vede la mia tristezza e la mia
solitudine.
M’addormenta e mi copre con un sasso
profumato”. (M. Chagall)
“Tutto questo è soprattutto un luogo,
più reale delle esistenze che vi si
succedono”. (Y. Bonnefoy)
di Gabriella Colletti

I battellieri del Volga (1870-1873)
Ilya Efimovic Repin
(Cuguev, 1844 -Repino, 1930)
San Pietroburgo, Museo Russo
Nella campagna russa sconfinate foreste di conifere e desolate steppe. Spazi che non finiscono mai. Scarsa la densità abitativa.
Qua e là sparute casupole di legno simili a cucce per cani. Una staccionata fatiscente e, oltre, un villaggio tra filari di betulle. Spostandosi dal magnifico centro storico di San Pietroburgo, la Nevskij Prospekt, verso la periferia, cresce il degrado. Si addensano tetri casermoni squadrati e massicci, palazzi lasciati cadere in rovina. Porte di lamiera. Alle finestre vetri rotti, malamente rattoppati. Sacchi di plastica per la spazzatura ammonticchiati sui marciapiedi. L’architettura nella zona dell’aeroporto muta radicalmente. Non è più la magnificenza imperiale, la celebrazione del potere degli zar attraverso sapienti ed estrosi architetti italiani - cortigiani di Elisabetta o Caterina la Grande che, tra Sette e Ottocento, edificarono splendidi palazzi barocchi e neoclassici -. È invece la celebrazione di Stalin ad imporsi con prepotenza allo sguardo. La glorificazione di un insetto nell’economia dell’universo. Un uomo meschino, non amante certo della bellezza. Una morsa stringe il petto. Ci si sente come animali dietro le sbarre di uno zoo. La statua gigantesca di Stalin troneggia al centro di un giardino. Gigantografie.
Sparite le dame dalle crinoline di bambola, le seducenti cortigiane con i loro giochi civettuoli e maliziosi; a prendere il sopravvento è l’immagine di una contadina russa senza un filo di trucco. Un viso precocemente invecchiato dal lavoro in fabbrica e a casa. Un fazzoletto rosso per copricapo le nasconde la chioma, che libera solo a tarda sera, agli occhi del marito, il quale non la guarda più come una volta, quando da ragazza la corteggiava. La routine fatta di stenti e fatiche ha logorato quel rapporto che fu d’amore e quelle chiome, ora grigie. Nessuna civetteria è consentita. Qualora esistesse, deve essere corretta sul nascere. La civetteria è immorale per il partito. Non si addice a una brava massaia e madre di famiglia. è necessario che fatichi, come un uomo. Anzi, come una bestia da soma.
Su quelle esili spalle grava, oltre al lavoro in fabbrica e nei campi, il peso della famiglia e delle faccende domestiche - attività, queste ultime, da cui l’uomo per convenzioni culturali è dispensato -. In tali condizioni l’adattamento è una questione di vita o di morte. La donna alza il dito indice sopra le labbra avvizzite, intimando il silenzio. Taci. Il nemico ti ascolta. Questo il soggetto di una vecchia stampa di propaganda al regime che vidi in un mercatino.
Trionfanti sotto ogni dittatura, burocrazia e terrore. Unica costante l’indigenza dei sudditi, prima servi della gleba sotto Pietro il Grande e Caterina, poi sotto Stalin, l’insetto che si fece creare gigantografie con la propria effigie di buon padre padrone. E chi osava denunciare la trappola spacciata per uguaglianza veniva messo fuori campo. Fatto tacere. Ammazzato. Internato in prigione o in manicomio. Furono anni di tetro cinismo e di presunti imperativi morali anteposti alla gioia e alla leggerezza di ogni essere umano. Nella lingua russa, d’altronde, non esiste la parola divertimento. Bisognava essere ligi al dovere. Sottomessi al potere coercitivo di uno Stato che deprivava i suoi figli persino del cibo. Tra i dogmi del comunismo, il lavoro era al primo posto. Eppure è sacrosanto aspirare a un’esistenza migliore, a un minimo di agiatezza, a svaghi e divertimenti, piuttosto che marcire in cucce per cani, regalate a operai e contadini dal regime sovietico. “Che cosa fare?” “Chi ha la colpa?”.
Sui campi sovietici è passato il collettivismo rurale, lasciandovi tracce indelebili. Il paradiso contadino non era nient’altro che sogno e utopia, rintracciabili nei quadri di Chagall e Burliuk. Animali parlanti, mucche volanti, bestie e paesani accomunati da un unico sentimento di fratellanza e amore. Immagino le fughe verso la libertà dei servi della gleba nel medioevo e, poi, dei contadini russi, i colchosi (da Kolchoz, azienda agricola sovietica ad organizzazione collettivistica di tipo cooperativo). Un fagottino con all’interno pochi oggetti personali, una fotografia, una ciocca di capelli: sognatori in marcia verso il paese della cuccagna. C’era chi fuggiva verso la città, augurandosi condizioni di vita migliori. E tornava nella sua terra di notte, in sogno, abbracciato alla sua sposa, volando sopra minuscoli villaggi dai camini fumanti.
Marmo bianco, un’altezza vertiginosa: lo scalone d’ingresso all’Ermitage.
Siamo immersi nella celebrazione del potere imperiale degli zar di Russia. Fasto e oro a profusione. Ogni suppellettile luccica, come se avesse imprigionato i raggi del sole per restituirli all’interno di quelle stanze, dimora di dei. Bellezza seduzione vertigine. Tra quelle mura ovattate non penetra il lamento del popolo. E all’esterno della reggia? Imperversano gelo miseria squallore, dolore e morte per stenti, per fame. Eppure il popolo russo, fanatico di Dio e dello zar - considerato alla stregua di un dio in terra come per i popoli primitivi - non si sognava neppure di desiderare un minimo di giustizia sociale, un pizzico di benessere per sé. Non gli passava nemmeno per l’anticamera del cervello. Furono i principi a voler portare libertà e democrazia. Per questo pagarono con la vita alcuni. E furono in tanti. Altri, condannati ai lavori forzati, andarono in Siberia. Le loro donne, sublimi donne russe, li seguirono, nell’estremo sacrificio. Grandi utopisti, non vollero la rivoluzione per sé, ma per il popolo. Tuttavia, il popolo non capì. Esultò davanti alla crudeltà dello zar. Approvò che la rivolta decabrista venisse soffocata con il sangue. Era il 14 dicembre dell’anno di grazia 1825. Uno spettacolo di morte. A centinaia morirono sotto i colpi delle armate fedeli a Nicola I. Nella piazza, che prese poi il nome dei ribelli, un bagno di sangue. Impotente di fronte a tanto strazio, il Cavaliere di bronzo con impeto guerriero impenna il suo cavallo dal 1782. Gli zoccoli schiacciano un serpente, simbolo di tradimento.
Un piccolo uccello simile a un passero - becco giallo, piumaggio scuro picchiettato di bianco - trillava ai primi raggi del sole. Uno stornello sui rami spogli contro il cielo tagliente, grigio come l’enorme massa d’acqua della Neva increspata dal vento. Volava basso, zigzagando impazzito per schivare la traiettoria delle mitraglie. Andò a sbattere contro un’alta finestra che schiudeva un mondo di bellezza e profumi soavi. Una selva di statue sul tetto osservava muta la scena. La finestra si apre, una graziosa mano inguantata prende con delicatezza, a pugno chiuso, lo stornello che non oppone resistenza. Dame si affacciano alla balaustrata d’oro, sorretta da possenti colonne corinzie. Fruscio di sete e broccati. Risa argentine. Piccoli passi. Voci. Una crinolina azzurra si siede su una poltrona d’oro e diviene una conca di tepore per lo stornello, che alza il piccolo capo a un giovane viso candido, spruzzato di lentiggini. Eleganti mani accarezzano la testolina, occhi grigioverdi vanno a una gabbietta d’oro su un tavolino.
è sera ormai, anche se sono le quattro del pomeriggio. L’oscurità confonde le pozze d’acqua con quelle di sangue sul lastricato della piazza. Il paesaggio spettrale è immerso nel silenzio. I capi della rivolta pendono dalla forca a monito dei più recalcitranti sovversivi. Il vento piega i rami degli alberi. Nel Palazzo d’Inverno la piccola cortigiana mostra con orgoglio lo stornello alle compagne. Il salone delle feste è un tripudio di luci per il gran ballo. A tarda notte il canto dello stornello si perde nel vento e somiglia al lamento delle vedove.
A distanza di quasi quarant’anni dalla strage dei decabristi, il caposcuola del realismo russo, Ilja Repin, ne I Battellieri del Volga (una grande tela ad olio, al Museo Russo di San Pietroburgo) ci restituisce l’agghiacciante atmosfera dei condannati ai lavori forzati. Simbolo di forza impotente, di dignità schiacciata. Le figure sprigionano grandezza epica; collocate al di fuori della contingenza storica, metafora di tutte le vittime oppresse di ogni tempo e regime. Sfiniti, piegati nell’indicibile ed inutile sforzo, uomini ridotti a bestie da soma trascinano un battello a riva. I piedi affondano nella rena, volti e corpi sferzati dal gelido vento siberiano.
Bistrò dell’Ermitage. L’anziana vigilante consuma un magro pasto: tazza di tè e cremino al cioccolato. Povertà e bellezza armonicamente fuse, in Russia un contrasto stridente, millenario. San Pietroburgo pullula di vecchi. Soprattutto donne. Penso alle più fortunate, quelle che riescono a trovare un impiego all’Ermitage come vigilanti. Non sarebbe possibile vivere nella metropoli di cinque milioni di abitanti con la pensione da fame che elargisce loro lo Stato, mentre i nuovi ricchi sono sempre più ricchi. Le ho viste al crepuscolo nelle immense gallerie dell’Ermitage appisolarsi come bambine felici - volti stanchi, mani rugose abbandonate in grembo – ignara la processione dei visitatori procedeva. Una sbavatura di rossetto rosso sulle labbra ancora belle sembrava accennare a un sorriso. Avrei voluto sapere cosa sognassero, davanti alle imponenti finestre con vista sul lungofiume che costeggia il palazzo. Nella logora scarpa di vernice bianca, ridotta oramai a ciabatta, un buco, un rammendo alla stinta sottana.
Le ho viste con la sporta della spesa al mercato, aggirarsi furtive e frugare in un cassonetto dove qualcuno più fortunato aveva gettato qualcosa. Passi frettolosi si allontanano verso una limousine. Tra svariate cianfrusaglie appare un vecchio cappotto fuori moda, ma in buono stato. Ciò che per altri è superfluo per le vecchine è essenziale.
Ordinari effetti della globalizzazione.
Un’auto sfreccia sotto un gigantesco arco di trionfo di ghisa color verderame. Il più grande arco di trionfo che abbia mai visto, colossale elogio del kitsch. Il comunismo non fece nulla per abbellire la città. Per lunghi decenni regnarono degrado e paura.
Unica costante: l’indigenza, che univa in un vincolo di indissolubile e triste fraternità operai dell’Urss e servi della gleba della vecchia madre Russia.
IMMAGINI
l violinista (1911)
Marc Chagall
(Liosno, 1887 -
St. Paul de Vence nel 1985)
Düsseldorf, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
Io e il mio paese
(1911)
Marc Chagall
New York, Museum of Modern Art
Il canto del gallo
(1944)
Marc Chagall
Proprietà: Collezione Katherine Smith Miller e Lance Smith
La passeggiata
(1917)
Marc Chagall
San Pietroburgo Museo Russo
Il poeta sdraiato (1915)
Marc Chagall
Londra, Tate Gallery
Lavandaie (1911) - Natalia Goncharova (Nagayevo,1881 - Parigi 1962) -
San Pietroburgo, Museo Russo
La tosatura delle pecore (1907) - Natalia Goncharova -

|