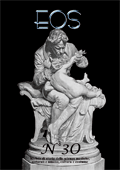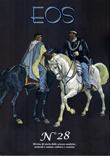|
Anno 10 - N. 30/ 2011
“Non amò mai in modo particolare l’opera, e frequentemente criticava la natura stessa dello spettacolo melodrammatico”.
Pietro Verri e il melodramma
“Non vi è niente che parli al cuore”
La battaglia contro le “pedanterie musicali”
di Alessandro Peroni

Ercole che combatte contro la morte per il corpo di Alceste
(1869)
Frederic Leighton,
(Scarborough, 1830 - Londra, 1896)
Sia durante gli anni del “Caffè”, sia in quelli successivi alla cessazione della pubblicazione della rivista, Pietro Verri continuò a frequentare assiduamente il teatro, e ciò anche quando la sua intensa attività nella pubblica amministrazione lo rendeva uno spettatore assai meno attento rispetto agli anni giovanili (si veda “Eos” n. 27).
Benché lo spettacolo più rappresentato a Milano, come nel resto d’Italia, fosse il melodramma, nessun articolo del “Caffè” è dedicato ad esso, sebbene in un saggio di Pietro Verri dal titolo La musica, molto apprezzato anche dagli Illuministi francesi, non manchino chiari riferimenti ai mali che affliggevano la composizione e l’esecuzione operistica.
Questo breve testo risentiva in maniera evidente del contenuto delle voci musicali dell’Encyclopédie, che costituivano un’imprescindibile fonte teorica per l’autore, ma vi erano ben presenti anche le abituali tematiche del “Caffè”, che si schierava anche sul fronte della musica, così come su quello delle lettere, contro il pedantismo:
“Io distinguo molto il giudizio de’ professori dal giudizio degli uomini che sono particolarmente affezionati alla musica. I professori per lo più, anzi che abbandonarsi senza prevenzione all’azione della musica e di giudicarne dall’effetto che fa nell’animo (il che sogliono gli uomini sensibili alla musica considerare per l’unica e vera pietra di paragone) invece [...] possedono esattamente le leggi dell’armonia e la maneggiano con ogni destrezza, come un facitor d’anagrammi [...] senza cercare nemmeno la strada per eccitare le passioni del cuore e senza provarle mai. […] Molte cose vi sono nella musica le quali mi sembrano affatto inutili e potrebbero chiamarsi pedanterie musicali”.
Le “leggi dell’armonia” rappresentavano, secondo una diffusa accezione razionalista, il fondamento della musica, tanto che nelle opere teoriche di vari autori (in particolare nei trattati più tardi di Jean-Philippe Rameau), esse venivano a costituire i principi di una vera e propria metafisica. Pietro Verri considerava questo tipo di argomentazioni pure “pedanterie musicali”, mentre, in linea con le opinioni degli autori dell’Encyclopédie come d’Alembert, Rousseau e De Chausac, riteneva piuttosto che la musica fosse una forma di espressione del sentimento comune a tutti gli uomini, la quale doveva essere giudicata in base al piacere che era in grado di offrire all’ascoltatore:
“Io preferisco que’ momenti beati d’un soave delirio che di tempo in tempo provo all’udire la vera musica a tutte le scoperte de’ problemi più elevati che possono farsi sulla natura di essa”.
Alla ricerca di una semplicità e di una naturalità espressive che sapessero realmente accendere le passioni, Pietro estendeva al virtuosismo dei musicisti (che li rendeva troppo spesso simili a dei funamboli da fiera) la critica già avanzata al pedantismo dei teorici. Entrambi erano espressioni di una tecnica fine a se stessa, priva della facoltà di comunicare al cuore un autentico piacere:
“Io ho ascoltato delle voci alle quali non si poteva rimproverare verun difetto, ma il mio animo faceva loro il rimprovero massimo poiché non sentiva nulla. I ballerini da corda si pagano perché ci faccian maraviglia; i musici si pagano perché ci movano: eppure la massima parte de’ musici vuol fare da ballerino da corda”.
La capacità di “eccitare le passioni del cuore” restò, infatti, il criterio al quale Pietro Verri sempre affidò il suo giudizio sulle esibizioni dei musicisti, come, ad esempio, quando udì cantare a Pavia, in occasione dell’inaugurazione del Teatro dei Quattro Cavalieri, uno dei più grandi fenomeni vocali del Settecento, la ferrarese Lucrezia Agujari, detta “la Bastardina”. In una lettera al fratello Alessandro, Pietro Verri ne riconosceva la tecnica eccelsa, ma ne criticava la scarsa comunicatività emotiva:
“Ho ascoltato per la prima volta l’Agujari detta la Bastardina; ha delle voci da angioletto che sorprendono e non si crederebbero uscite da una bocca umana; per altro io credo che dopo due o tre volte non sembrerà più cosa meravigliosa, perché poco va al cuore” (7 luglio 1773).
Espressioni simili si trovano anche nel giudizio su uno degli ultimi grandi castrati del XVIII secolo, il capricciosissimo Luigi Lodovico Marchesi, detto “il Marchesini”:
“La bella sua voce è passionata, tenera, compassionevole, e io non l’ho trovato in alcuno fra i cantanti. Egli ha tutto adunque. Solamente gli manca, credo, il sentimento, che sa toccarti nell’anima”.
E così, dopo averne lodata la tecnica perfetta (eppure fine a se stessa), il Verri concludeva definendolo “un non senso maraviglioso” (19 febbraio 1780).
“L’Alceste tetra e terribile”
L’estrema sensibilità musicale di Pietro Verri contribuiva senza dubbio a rendergli poco gradite le numerose opere che, composte frettolosamente da autori di scarso rilievo, passavano regolarmente sui palcoscenici milanesi. Ogni volta, ne spediva al fratello brevi commenti, talora non privi di infastidito biasimo. Verri, in realtà, non amò mai in modo particolare l’opera, e frequentemente criticava la natura stessa dello spettacolo melodrammatico.
Tale giudizio negativo era, in realtà, assai diffuso presso molti intellettuali italiani ed europei. Nonostante il rispetto e il consenso di cui universalmente godeva il Metastasio (il sommo poeta che da decenni dettava le regole del melodramma), l’opera italiana era ormai diventata un genere formalmente e artisticamente stanco e ripetitivo, carico di lungaggini e pesanti recitativi che ne portavano la durata a diverse ore. La maggiore attrattiva consisteva così nelle arie cantate dai virtuosi, sicché la fatica di poeti e compositori era tutta volta a creare pretesti per le esibizioni (spesso improvvisate) di castrati e primedonne.
Dopo anni di pubblico dibattito e scritti polemici, finalmente l’iniziativa per una riforma del melodramma partì dal livornese Ranieri de’ Calzabigi, straordinaria figura di avventuriero, poeta ed economista. Proprio a Vienna, dove il Metastasio viveva come una sorta di secondo monarca e dove il Calzabigi ricopriva il ruolo di consigliere economico di corte, egli riuscì, grazie all’appoggio del conte Durazzo, direttore generale dei teatri imperiali, a scrivere ed allestire con successo la prima opera ‘riformata’, l’Orfeo ed Euridice (1762), che fu musicata da Cristoph Willibald Gluck. Tuttavia, l’opera che costituisce il primo esempio perfettamente compiuto della “riforma” fu l’Alceste, composta ancora da Calzabigi e Gluck, che andò in scena il 26 dicembre 1767 al Burgtheater di Vienna. Ancor più dell’Orfeo, l’Alceste era un esempio di rigore compositivo, nel quale, pur non rinunciando alle forme classiche, poesia e musica si ponevano al servizio delle esigenze del teatro. Fatto molto raro per l’epoca, e tuttavia necessità non trascurabile per il successo della riforma stessa, quest’opera non solo fu composta in stretta collaborazione dai due autori, ma anche data immediatamente alle stampe, con una prefazione firmata da Gluck (anche se ispirata direttamente dal Calzabigi), che rappresentava il manifesto programmatico della riforma del melodramma: “Quando mi accinsi a mettere in musica l’opera Alceste, mi proposi di evitare tutti gli eccessi che una malintesa vanità dei cantanti e l’eccessiva compiacenza dei compositori avevano introdotto nell’opera italiana, trasformando lo spettacolo più solenne e più bello, nel più noioso e più ridicolo; io cercai di ridurre la musica alla sua vera funzione, cioè di assecondare la poesia per rafforzare l’espressione dei sentimenti. [...] Fortunatamente il poema si prestava a meraviglia alle mie intenzioni; il celebre autore dell’Alceste [Calzabigi], avendo concepito un nuovo tipo di dramma lirico, aveva sostituito alle descrizioni fiorite, alle inutili analogie, alle fredde e sentenziose allegorie, situazioni interessanti, il linguaggio del cuore e uno spettacolo sempre vario. Il successo riportato ha dato ragione alle mie idee, e l’universale approvazione di cui ho goduto in una città così illuminata [Vienna] mi ha dimostrato che la semplicità e la verità sono i grandi principi del bello in tutte le produzioni artistiche (C.W. Gluck, Prefazione all’Alceste).
Se l’interesse per le nuove opere di Gluck e Calzabigi si risvegliò in tutta Europa, la “riforma” non arrivò però a Milano, più che altro per colpa degli impresari del Teatro Ducale, i quali non avevano fiducia nella possibilità di successo di un’opera così stilisticamente lontana da tutto ciò che andava regolarmente in scena sul palcoscenico milanese. Eppure, non potendo passare sotto silenzio il dramma di Calzabigi, che tanto scalpore aveva riscosso l’anno precedente nella capitale imperiale, il potente impresario Antonio Greppi e gli altri appaltatori del Ducale decisero di metterlo in scena nella stagione di carnevale del 1769, affidando però l’ingrato compito di una rielaborazione letteraria a Giuseppe Parini, allora poeta incaricato del teatro, e il rifacimento completo delle musiche al modesto Pietro Guglielmi. La nuova Alceste andò in scena con gran pompa il 26 dicembre 1768 all’apertura della stagione. Sul programma si indicava: “Poesia di Calzabigi rifatta da Parini. Musica di Pietro Guglielmi”.
Il parere espresso in una lettera al fratello da Pietro Verri sull’approssimativa realizzazione milanese fu breve e impietoso:
“Abbiamo un’opera del Calzabigi, l’Alceste; tetra e terribile, ma eseguita in modo che si vede che non basta solo voler spendere per avere un buon teatro; pure, siccome non v’è da scegliere, così non mancano spettatori” (7 gennaio 1769).
Esempio, dunque, di cattivo teatro, l’Alceste milanese rappresentò in realtà un’occasione perduta per il pubblico della città lombarda. Lo stesso Verri, di solito piuttosto informato, sembrava ignorare che l’“opera del Calzabigi” a cui aveva assistito rappresentava in verità un vero e proprio tradimento degli intenti e degli ideali drammatici dell’autore, e questo nonostante la nota posta in apertura del libretto stesso da un contrito Parini: “Dei cambiamenti che si è osato fare in questa moderna tragedia per musica, si spera perdono dall’applaudito Autore [Calzabigi], non essendosi fatto per intendimento di migliorare, ma per accomodarsi alle presenti inevitabili circostanze del nostro Teatro”.
Eppure, lo stesso Calzabigi, in una lunga lettera al Greppi datata 6 aprile 1768, aveva diffidato l’impresa milanese dal mettere in scena il suo dramma in una versione adulterata: “Essendomi io animato a cambiare il piano de’ nostri spettacoli musici, mi sono ancor prefisso di bandir dal mio nuovo tutte le inconvenienze dell’antico. Non [...] mi sono adattato a servire colla mia poesia al commodo de’ cantanti (abuso troppo ridicolo) ma ho inteso che i cantanti servissero al mio […]. Se l’Alceste fosse prolungata [...] già sarebbe difettosa perché non è possibile fermare l’attenzione degli uditori, e incatenare il loro interesse al di là d’un certo tempo che io mi son limitato alle due ore in circa”. L’opera, per il Calzabigi, doveva quindi avere una durata ridotta, affinché l’attenzione del pubblico non scemasse. Al contrario, gli impresari milanesi erano del tutto insensibili ad un simile argomento: essi desideravano uno spettacolo più lungo e scenografie più ricche, ben lieti, fra l’altro, che, per sfuggire alla noia di un’interminabile rappresentazione, gli spettatori si spostassero ai redditizi tavoli da gioco presenti nel ridotto del teatro. Al Calzabigi fu così impossibile fermare lo scempio della sua opera “riformata”, fatto di cui fu informato da una missiva dalla ballerina Teresa Fogliazzi. Così, il poeta livornese, pochi giorni prima che l’opera andasse in scena, inviò un’ironica lettera al Greppi: “Mi prevenne [...] la Signora Teresa della fiera mutilazione da loro ideata della mia Alceste o più tosto amplificazione [...]. Comunque sia, deploro, non come Poeta, ma come homme de goût il barbaro governo che fanno adesso in Italia alle produzioni teatrali più sensate a solo motivo di tirarle alla ridicola durata di cinque ore e di poter cenare mentre si rappresentano”.
Presso i Milanesi, il dissidio tra l’autore e gli appaltatori passò pressoché inosservato, tanto da sfuggire, come si è visto, anche allo stesso Verri. La mancata rappresentazione a Milano della versione originale dell’Alceste privò così il pubblico lombardo della possibilità di confrontarsi con i riformatori viennesi del melodramma e di apprezzare quanto di nuovo veniva proposto nella capitale imperiale. Sebbene Milano non restasse, per questo fatto, culturalmente isolata dal resto d’Europa, pure l’opera vi rimase nei decenni successivi di fatto ancorata alla più retrive convenzioni del genere.
Qualche anno dopo, nel 1771, Pietro si stupiva che dall’Austria, e non dall’Italia, venisse la tanto attesa riforma del melodramma:
“Io credo che un’opera italiana non possa durar più di due ore, se ha da piacere. L’Orfeo, l’Armida e simili, fatte a Vienna, non durarono di più [...]. Probabilmente questo gusto lo vedremo a venire in Italia. E chi l’avrebbe mai detto che Vienna dovesse diventare il punto d’appoggio per le belle arti! [...] A Vienna si amano gli spettacoli” (13 novembre 1771).
Dall’Europa riconosciuta
al “teatro d’Italia”
Verri ebbe un improvviso ritorno di entusiasmo per l’opera solo in occasione dell’inaugurazione della Scala, allorché l’Europa riconosciuta di Mattia Verazi, con la musica di Antonio Salieri, lo colpì per la bellezza dell’allestimento:
“Tutto è magnifico e pomposo. [...]. Il dramma poi che si recita è composizione di certo signor Verazi, romano, uomo che non è poeta né di lettere, ma teatrale; ha della immaginazione, e della pratica fatta fuori d’Italia. [...] Il libro non ha né capo né coda, ma lo spettacolo piace perché sempre variato: le arie sono corte e frequenti; ora duetti, ora a tre, ora cori mischiati e interrotti coll’attore. Gli occhi sono sempre occupati, e l’udito non si annoia colla uniformità” (5 agosto 1778).
Verri, evidentemente non apprezzava le doti letterarie del Verazi, pur definendolo uomo “teatrale”. Poeta di corte dell’Elettore di Baviera, costui si atteggiava a innovatore dell’opera, muovendosi però in direzione diversa rispetto al Calzabigi: era suo convincimento, infatti, che ciò che del melodramma andava esaltato fosse principalmente la spettacolarità. L’ambizione del librettista dell’Europa riconosciuta venne, peraltro, bene assecondata dagli scenografi, i fratelli Galliari, veri trionfatori, insieme ai castrati Pacchiarotti e Rubinelli, della grande serata inaugurale. Anche la musica di Antonio Salieri, all’epoca direttore del Teatro Italiano di Vienna e della Cappella Imperiale (gentilmente prestato per l’occasione all’Arciduca di Milano, Ferdinando d’Asburgo), risultò gradita al Verri, che apprezzava la brevità delle numerose arie ed il ricorso a forme musicali a più voci (duetti, terzetti e cori). Probabilmente la maggior parte dei milanesi non si rese conto che, con la musica di Salieri, era finalmente arrivata anche a Milano la riforma del melodramma: il compositore legnaghese era infatti un convinto sostenitore di Gluck e, per quanto il libretto del Verazi fosse lontano dalla poetica del Calzabigi, pure la musica superava la tradizionale interminabile alternanza di arie e recitativi per differenziarsi in forme concertate di maggiore complessità.
Tuttavia, pochi giorni dopo, Pietro annotava come il grandioso spettacolo dell’Europa riconosciuta, dopo diverse repliche, andasse già perdendo il fascino iniziale:
“Lo spettacolo, sebbene dispendiosissimo, va poco a poco annoiando perché non vi è niente che parli al cuore. Gli occhi sono stati abbagliati per un momento; ora freddamente osservando per la quarta e decima volta lo stesso oggetto, cessata la sorpresa, se ne sente il vuoto e l’inconseguenza” (15 agosto 1778).
La tanto attesa inaugurazione del Teatro alla Scala e la delusione dell’Europa riconosciuta dopo gli entusiasmi iniziali furono gli eventi che, pochi giorni dopo, spinsero Pietro Verri a scrivere al fratello una lunga lettera che, per le sue numerose riflessioni sul teatro, rappresentava il bilancio di decenni di frequentazione degli spettacoli e di battaglie per la loro riforma: “Lo spettacolo della nostra opera sempre più decade malgrado le belle voci, musica, e decorazioni. Sul proposito io azzarderò il mio sentimento, ed è che è impossibile l’inventare uno spettacolo, il quale rappresentato trenta giorni di seguito agli stessi uditori, possa continuare a piacerli e conciliarsi la loro attenzione”.
Pietro esprimeva poi i propri dubbi circa la possibilità e l’opportunità di riformare il melodramma. Si trattava, in un certo senso, di una resa di fronte alle consuetudini teatrali italiane, e comunque di una resa non particolarmente dolorosa per lui, che, pur nel suo grande amore per la musica, non aveva mai troppo amato l’opera:
“Mi chiederai, dopo ciò, se dipendesse da me cosa farei dell’opera; ti rispondo: la lascerei presso a poco nel suo disordine, e se potessi mi rivolgerei alla commedia, e alla tragedia, fabbricando de’ piccoli teatri, ne’ quali la voce dell’attore fosse ascoltata senza l’inverosimile sforzo de’ nostri istrioni; procurerei di formare una compagnia di bravi attori; comincerei a far rappresentare il meglio che vi è di nazionale e delle traduzioni, e non dubito che la possibilità di vedere ben rappresentate le produzioni darebbe scossa agli ingegni d’Italia, e chi ha del genio si porrebbe a scrivere. Così si realizzerebbe il teatro d’Italia, e nel costume s’introdurrebbe quel fiore di urbanità di cui manchiamo”.
L’opera era quindi uno spettacolo disordinato, e al suo disordine andava lasciata, destinandola ai grandi teatri. Al contrario, la commedia e la tragedia avrebbero dovuto essere rappresentate diffusamente anche in Italia, come già avveniva in altri paesi europei come la Francia e l’Inghilterra, ed essere ben recitate in teatri di dimensioni adeguate. Questi generi teatrali, fino ad allora piuttosto trascurati nella Penisola, avrebbero finalmente risvegliato gli “ingegni d’Italia”, coniugando così l’ideale del teatro come mezzo di educazione civile (un tema su cui Verri aveva ampiamente scritto in passato) a quello più recentemente concepito del “teatro d’Italia”. Pietro, nella stessa lettera, si spingeva oltre, ed elaborava un piano dettagliato per fondare una “compagnia di bravi attori” professionisti, un’iniziativa che avrebbe potuto facilmente realizzarsi con l’appoggio di un sovrano o di un principe illuminato. Tuttavia, egli non sembrava farsi troppe illusioni circa la possibilità che in Italia si realizzasse questo progetto:
“Ma questa bella idea, la quale non costerebbe a un piccolo principe che il volerla, non cade in mente [...]. Resterà anche da vedersi se mai [...] il dispotismo di alcune opinioni, l’inquieta attività d’una nazione vivace e la divisione dell’Italia in tante dominazioni staccate, piccole e diverse nel loro sistema politico, non siano un ostacolo a quella gioconda e facile vita sociale che raduna i simili a convivere passando bene il loro tempo, senza bisogno d’uno spettacolo intorno cui periodicamente collocarsi per quattro ore di ogni giorno” (19 agosto 1778).
Cosa restava allora ai popoli di questa Italia divisa? Evidentemente solo il melodramma, ossia quello “spettacolo intorno cui periodicamente collocarsi per quattro ore di ogni giorno”, una sorta di lugubre rifugio, consolatorio dell’impossibilità di vivere “quella gioconda e facile vita sociale” nella quale, magari, si poteva proficuamente assistere alla commedia o alla tragedia. Pietro esprimeva così il suo cupo pessimismo riguardo il futuro del teatro italiano, anche perché le motivazioni politiche troppo spesso prendevano il sopravvento su quelle estetiche e drammatiche. Così, pure nella familiare ed amatissima cornice del teatro milanese, l’onnipresente potere degli Asburgo imponeva la sua legge:
“Da noi niente rimane di repubblicano nel teatro, non si fa ripetere verun’aria se il R. Arciduca non si mostra a battere le mani; egli per lo più ha questa compiacenza quando la platea comincia, ma qualche volta non l’ha, o è ritirato in una stanza, e allora non si replica. La nostra opera è fredda in tutti i sensi, e si è speso quanto basta per farne una buona; hanno cercato che tutto fosse buono, e non si sono curati che almeno qualche cosa vi fosse di eccellente [...] Il vasto teatro è vuoto e questo disanima.” (9 gennaio 1779).
L’insopportabile ingerenza del potere e delle convenzioni ad esso legate, così come la mediocrità generalizzata degli allestimenti, avevano portato alla diserzione del teatro da parte dei Milanesi: a sei mesi dall’inaugurazione, il fallimento della grande impresa della Scala era ormai sotto gli occhi di tutti.
IMMAGINI
Ritratto di Pietro Verri
(Milano, 1728 - 1797)
Ritratto di Lucrezia Agujari “la Bastardina”
(Ferrara, 1743 -Parma, 1783)
Ritratto attribuito a Pietro Melchiorre Ferrari (1735-1787)
Ritratto di Luigi Ludovico Marchesi “il Marchesini”
(Milano, 1754 - Inzago, 1829)
Disegno di Richard Cosway (1742-1821)

|