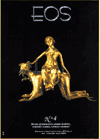|
Anno 2 - N. 4 / 2003
DALL’ALBERO ALL’ARCHITETTURA
Natura e mente entrambe soggette alla medesima legge
o della naturale definizione dello spazi
di Daniele Garnerone

Parco Güell, Barcellona (1900-1914)
Antoni Gaudì) (Riudoms,1852 – Barcellona,1926)
È dal XVII secolo che prende consistenza in termini analitici la tematica del paesaggio. Dunque, un’attenzione relativamente moderna che corrisponde ad un mutamento delle condizioni culturali che consentono di considerare il paesaggio anche in quanto risultato di conoscenza e di coscienza. Ciò non significa che prima non vi fosse una coscienza del paesaggio in quanto riflesso spaziale sul territorio, delle interazioni tra natura ed attività o processi di trasformazione dipendenti dalle attività umane. Ma l’atteggiamento verso il paesaggio è stato a lungo condizionato da una parziale – o mancata – autonomia, come se fosse “inconsapevole” o determinato da eventi e processi non indagati in quanto agenti di trasformazione territoriale, proprio perché l’attenzione era posta sui medesimi agenti in quanto fondanti i rivolgimenti storici, le discipline artistiche, i processi socioeconomici. In un certo senso ed usando – ma ne sono consapevole – forzatura, il paesaggio costituiva un elemento necessario alla rappresentazione di qualsiasi momento della vita, reale od immaginata, senza che ad esso fosse riconosciuta una propria specifica valenza: paesaggio come sfondo senza autonomia rispetto a ciò che ospitava: campi, aggregati di case, scorci urbani, montagne o cielo tempestoso che fossero.
Per comprendere come si sia formata tra la fine del Settecento ed ancor più nell’Ottocento una coscienza del paesaggio è necessario riferirsi alla filosofia della natura nel Seicento. Negli scritti di Spinoza appare delineata la natura intelligente (l’idea, la legge) che si confronta e si integra nel processo costitutivo della forma dello spazio con il pensiero e la coscienza (1). Natura e mente entrambe soggette alla medesima legge.
Svincolata dalla rappresentazione allegorica o alla mitizzazione degli eventi, la natura intelligente assume una propria consapevolezza. Una linfa vitale che anima e struttura la natura, verso la quale l’interesse si sovrappone e si integra con il gusto del bel paesaggio, divenendo predominante anche grazie all’affermarsi della pittura paesaggistica e alla letteratura del viaggio: Goethe parla della natura che “ha pensato e non cessa mai di pensare” (2). Se nella natura vi è un’amplificazione dell’intelligenza e del pensiero, pure Goethe va oltre il regno animale e vegetale individuando una attività pulsante nelle montagne. Nel Viaggio in Italia egli individua negli “amici della natura e dell’arte” un’interazione e reciproca integrazione tra elementi orografici, monumenti artistici, rovine e permanenze classiche, insediamenti umani e paesaggi agrari (3). Anche per Schelling, del resto, “l’architettura ha di preferenza l’organismo delle piante” (4). Goethe analizza il progetto interno della natura e Schelling, ma non è l’unico, individua nella manifestazione inorganica dell’architettura la matrice organica dell’albero.
Tra maestri e pensatori, dunque, un comune atteggiamento indagatore rivolto alla natura per interpretare le specifiche valenze dell’architettura.
Diderot esprime rammarico per l’opera dell’uomo che non attinge adeguatamente agli insegnamenti della natura maestra ed all’osservazione auspicabile nelle applicazioni tecniche dell’uomo. Vi si legge: “Quando volgo il mio sguardo ai lavori degli uomini, e vedo ovunque città edificate […], i porti costruiti […]: il mondo mi sembra molto vecchio. Quando invece scopro che gli uomini sono ancora incerti sui primi principi […] dell’agricoltura, […] sulla potatura degli alberi, sulla forma da dare all’aratro… la terra mi sembra abitata solo da ieri” (5).
In epoca gallica i campi erano sovente delimitati da alberature, quando non circondati da boschi di querce; nonostante le ingenti opere di trasformazione con apertura di nuove strade, bonifiche, sbancamenti, fortificazioni avviate sotto la colonizzazione romana, i boschi erano sottoposti a tutela di legge; in parte formavano l’ager pubblicus, in parte erano sacri. In molti casi, i filari alberati costituivano i limiti di proprietà; il paesaggio conseguente era quello dei campi chiusi, con la scarsa presenza di edifici compatti, in massima parte costruiti utilizzando esclusivamente il legname.
Col regresso dell’agricoltura durante la crisi dell’impero romano d’occidente vi fu un ritorno alla pastorizia ed alla caccia. Tra V e X secolo la selva prese nuovamente il sopravvento sulle terre messe a coltura. Toponimi come Selvanesco, Rogoredo, Brugherio, Nosedo, Carpiano, Castagneto, Cerro Maggiore, Cerro al Lambro e Cesano Boscone restituiscono il senso dell’immensa foresta nella quale cervi e daini, cinghiali e lupi dimoravano, rappresentando da un lato il mistero e la paura dell’ignota foresta e dall’altro l’ambito bersaglio delle battute di caccia dei Signori del luogo. Il processo di distruzione dell’originaria foresta lombarda si conclude dopo la metà dell’Ottocento, con il diboscamento del Bosco della Merlata che arrivava ai bordi di Milano. Restano il Bosco Negri, sulla sponda orografica destra del Ticino, il Bosco Fontana, nei pressi di Mantova.
È conseguente una riflessione sul passaggio dall’albero all’architettura, dalla natura al paesaggio che è architettura in quanto prodotto dell’attività e dell’insediamento umano, in una continua rielaborazione che meglio comprendiamo se ci riferiamo all’uso consolidato da secoli di potare e di allevare gelsi o salici a capitozza, platani a candelabro, frassini a scala, meli e peri ad ombrello, questi poi assieme ad altri alberi – da frutta e non – e maritati (come l’olmo e la vite dell’appennino tosco-umbro-marchigiano), riuniti e diffusi su migliaia di ettari di campagna in geometriche coltivazioni.
In una carta del 1743, la Possessione Grande, nel territorio bolognese di S. Maria Maddalena di Cazzano, è rappresentata con meticolosa precisione; dal cascinale con la torre colombaia alla stalla con il porticato ad altri casottini, all’aia circolare, al maceratore, dall’orto ai prati, ai campi. Ma ciò che maggiormente si nota è l’ordinatissima piantata, un perfetto allineamento di alberi da frutto, di mori (gelsi), di vincara. Un disegno regolare per fasce equidistanti a delimitare gli appezzamenti del fondo. Analoga suggestione provo nell’osservare il dipinto famosissimo di Anonimo fiammingo del Settecento, raffigurante un’azienda agricola nel territorio bolognese; qui la rilevanza delle ordinate alberature da frutto a filare tra i campi a semina è amplificata dalla visione prospettica e tutto concorre alla definizione di una campagna che appare come un giardino, deliberatamente progettato e, per questo, maggiormente contrastante con l’irregolare definizione spaziale dei campi e delle macchie boschive in lontananza, sino al limitare della città che si coglie distinta, dominata dalle torri.
La piantata padana trae origine da una innovazione agraria del XV secolo, tesa ad integrare l’economia a seminativo nudo con l’apporto di alberi preposti a fornire legname da ardere, sostegni, pali e strame. L’albero da scalvo e da cima è impiegato anche come sostegno alla vite e riconquista massicciamente una pianura rimasta per secoli caratterizzata dal paesaggio dei campi aperti. Un ritorno dell’albero nelle campagne dopo la distruzione della foresta originaria, attraverso una evoluzione che si completerà nelle forme caratteristiche della piantata nel corso del XVIII secolo quando, accanto al ritiro del gelso, della vite e alla coltura promiscua dell’altopiano, si assiste all’affermazione dell’olmo, dell’acero e, soprattutto, del pioppo nella bassa irrigua, particolarmente lungo le capezzagne e di bordo ai corsi d’acqua, in quell’inestricabile e diffuso sistema irriguo che ha costituito il presupposto strutturale per l’affermazione capitalistica della grande azienda agricola e della cascina. Lungo fossi e canali, a lato delle strade, al limitare dei campi le piantumazioni definiscono il paesaggio, secondo modalità consolidate da secoli alle quali concorrono manifeste volontà di abbellimento. Il canale è rafforzato da filari di alberi che delimitano le proprietà fondiarie e rafforzano gli argini.
Al ritmo delle opere idrauliche, i filari contribuiscono in maniera determinante a definire un paesaggio specifico.
Segnalo un luogo a me molto caro e significativo – scelsi l’immagine per la copertina della tesi di laurea – scoperto in anni non lontani in uno dei viaggi di trasferimento dal milanese al cuneese, lungo un itinerario attraverso la viabilità statale e provinciale. Immersa nella grande pianura del riso, la strada attraversa una fitta rete irrigua e, a ridosso delle colline del Monferrato, nel comune di Desana (Vercelli), fra gli altri, è il Cavo Provana, del XVI secolo, che sorprende per le sponde fittamente alberate per un lungo tratto; due filari di platani, non molto alti, non più di tre/quattro metri alla capitozza. Sul finire degli anni Ottanta l’alberatura era rigogliosa, più tardi mi resi conto che non pochi platani, per lo più prossimi al ponte, erano stati tagliati; tal’altri si trovavano in evidente condizione di sofferenza. Peccato, il minimo che si possa dire, ma aggiungo che è un errore, grave mancanza di sensibilità e di ragionevolezza non ripiantumare adeguatamente.
Il ruolo delle alberature è chiaramente dichiarato; dunque la vicenda dei rapporti tra albero e architettura e, ancora più specificamente, tra albero ed infrastrutture si basa su una secolare vicenda, un legame forte già dal XVII secolo.
Verso la fine del Seicento la scarsità di legname da ardere – principalmente dovuta alla mancanza di una visione complessiva delle risorse, quindi ad un uso non regolato del bosco con dissodamenti e diboscamenti anche abusivi – induce ad un piano grandioso di piantumazione lungo le strade. Più tardi, già nel Settecento, soprattutto in Francia, i canali sono coinvolti nel programma; gelsi sono piantati sul Canal du Midi, noci sul Canal d’Orléans, pioppi e platani sono distribuiti abbondantemente sul territorio, mentre lungo i canali stessi vengono insediati vivai per la produzione su vasta scala. L’esigenza rimarrà forte almeno sino all’inizio dell’Ottocento. Il programma di costruzione di nuovi canali, in Francia, subisce un forte impulso tra Settecento ed Ottocento, conseguente alla scarsità di legname disponibile; laddove è maggiore la richiesta (consumo) soprattutto in prossimità dei centri abitati più grandi la riduzione della superficie boscata è pressoché indistinta.
I canali di Orléans e di Nivernais (fine 600 e inizi 700, appunto) sono realizzati per trasportare il legname, materia prima per eccellenza per le costruzioni – edifici ma anche la flotta navale – e per il riscaldamento, verso le città ed i porti.
Non sono solamente gli aspetti tecnici che sovraintendono al progetto del Canal de Bourgogne, ma anche considerazioni in ordine ai valori estetici dell’opera nel suo complesso. Un forte senso dello spazio e del paesaggio ispira il progetto con cui nel 1810 J. Foucherot ridefinisce l’impianto del ponte-canale di Saint-Florentin, ipotizzando case, alberature e percorsi di collegamento alla vicina strada imperiale. Alla confluenza della Bourgogne nella Yonne, l’avamporto di La Roche diviene poi occasione per realizzare un’opera idraulica permeata di monumentale plasticità mediante l’uso combinato di un gran numero di pioppi e di obelischi (6).
L’ingegnere Robillard redige un preventivo per la piantumazione delle sponde di un canale: è il 20 dicembre 1814. Vi si legge: “I sentieri di alaggio, per ogni ritenuta, saranno piantumati con alberi della stessa essenza. Le piattaforme delle chiuse saranno tutte esclusivamente piantumate con castagni che non verranno mai potati. In questo modo, tutte le gore saranno decorate uniformemente, i punti di riposo offriranno tutti dell’ombra e le chiuse, coronate, forniranno il mezzo per leggere nella campagna tutte le cadute del canale. Per prevenire gli inconvenienti dell’ozio e per migliorare a poco prezzo la sorte dei custodi delle chiuse, le golene, sui due lati della loro abitazione, saranno piantumate con alberi da frutta” (7).
Gli alberi segnano il territorio assecondandone le forme, le curve di livello; l’ambiente “naturale” si confronta e si integra con il nuovo paesaggio, più ampio e complessivo, di natura-natura e di natura-artificiale (ma non artificiosa o, perlomeno, non nelle intenzioni dei progetti più consapevoli e validi). Un progetto grandioso che si avvale di ampie disponibilità in linea teorica, tali e tante sono le occasioni da sfruttare e rendere al nuovo linguaggio delle alberature.
Alberi in campagna, a filare o a macchia regolarizzata da disegni a griglia per la produzione di frutta o legname da cellulosa. Alberi fastigiati e allineati a filari multipli a magnificare i percorsi di accesso alle città, soprattutto platani, ma anche castagni, a delimitare con quinte vegetali viali e piazze, anche in maniera dichiaratamente maestosa com’è il caso arcinoto – per restare Oltralpe – del Cours Mirabeau di Aix-en-Provence – aperto nel 1649 sul sedime delle mura medioevali – dove più che le belle cortine edilizie sette/ottocentesche è il quadruplo filare di platani, ormai secolari e di dimensioni impressionanti, che costituisce l’elemento di maggiore riconoscibilità e di identità dello spazio centrale dell’antica capitale della Provenza.
A Cuneo, il Viale degli Angeli ha oltre 250 anni. La città alla fine del XVIII secolo era una roccaforte chiusa da mura che ne avevano contenuto l’espansione; in quel contesto maturò l’idea di un grande viale alberato, “una Lea o sia stradone attorniato di frondosi alberi” (8); era il 16 luglio 1720. Trent’anni dopo, il Consiglio della Città riprese il progetto per “darsi esequzione alla formazione della strada in linea retta sino al Convento della Madonna degli Angioli per comodo de’ Cittadini sia per un passeggio sia per promuovere vieppiù la divozione al beato Angelo, come già è stato negli ordinati antichi determinato”.
Il Viale degli Angeli fu disegnato secondo uno schema “alla francese”, al tempo del tutto sconosciuto in Italia (solo dopo la conquista napoleonica è avviata su ampia scala la realizzazione di consistenti alberature lungo le strade, con progetti che interessano città grandi e piccole). Dapprima furono impiantati olmi e tigli provenienti da Certosa di Pesio, poi nel tempo affiancati da ippocastani, platani, aceri, bagolari e liriodendri in proporzione variabile; il viale fu nel corso dei secoli interessato da momenti di splendore ed altri di decadimento, alternati a fasi di ricostituzione del vasto patrimonio arboreo, costituito da oltre 1300 alberi lungo i tre chilometri di sviluppo.
A Barcellona, le Ramblas, asse stradale lungo tre chilometri tra Plaça Catalunya e il mare, è uno spazio pubblico fortemente caratterizzato da cinque viali alberati; luogo di passeggio, bancarelle, negozi, caffè e residenza. Tutto un po’ caotico oggi, certo; grazie tante, ma è pur sempre un bazar in un bosco! La strada diventa così occasione anche di magnificazione dei percorsi, delle distanze, della prospettiva, in un complessivo disegno dello spazio progettato su misura per il godimento estetico e funzionale. Le alberature disposte a filare semplice o doppio strutturano con imponenza le grandi vie di comunicazione o più lievemente le strade minori, garantendo alle une e alle altre comunque una adeguata ombreggiatura ed il conseguente sollievo ai viaggiatori; la velocità, a questo punto, è solo un dettaglio: “Da Milano al Gottardo per Como e Bellinzona. Per ferrovia. Dalla Stazione Centrale la linea volge tosto a NE per Sesto e Monza in una plaga di innumerevoli stabilimenti di ogni genere tra cui […]. Il Parco al di là della Villa Reale, è aperto al pubblico da mattina a sera. Fu piantato nel 1806 dal vicerè […]. Questo percorso, fresco tra viali ombrosi, in parte pittoreschi, suscettibile di molte varianti, richiede circa ore 1,30 in carrozza” (9).
Il giardino ed il parco sono considerati bene culturale, alla stregua di un castello o di un centro storico, a partire da anni relativamente a noi vicini. Ad Assunto ci si riferisce, in particolare, quando si indaga il giardino storico come un “luogo destinato a vivere la contemplazione e a contemplare la vita nell’atto stesso del viverla: […] opera d’arte il cui godimento si identifica con il vivere in essa” (10).
Un punto di riferimento importante in merito ai giardini del territorio lombardo è sicuramente Giacomo Bascapè; la sua Arte e storia dei giardini di Lombardia, del 1962, e la Mostra storica dei giardini e parchi in Lombardia, del 1959, sono contributi fondamentali.
Lo studio arriva sino alla metà dell’Ottocento ed esclude dunque tutta la vicenda dei giardini pubblici e dei parchi privati realizzati tra la seconda metà dell’Ottocento ed i primi decenni del Novecento, con opere che fanno capo ad Emilio Alemagna, Antonio Citterio, Giuseppe Balzaretto. Dalla fine del Settecento si manifestano nuovi caratteri nei giardini lombardi ma “[…] la concezione architettonica del giardino all’italiana sopravvisse in molti casi, in aperto contrasto con la gran voga del parco boscoso ed irregolare (11).
Fra i sistemi di ville del patriziato milanese organizzati lungo i corsi dei navigli, scelgo qui quello di Cernusco sul Naviglio, sulla Martesana, e quello di Cassinetta di Lugagnano, sul Naviglio Grande.
A Cernusco il sistema è organizzato in due fasce, una interna al tessuto edificato, l’altra esterna, aperta alla campagna ed oltre il Naviglio della Martesana. Complessivamente, dominano lo spazio i complessi della Villa Alari Visconti, di Villa Uboldo e di Villa Biancani Greppi; emergono sul tessuto edificato del centro storico, costituendo poli fortemente caratterizzati dalle masse e dall’architettura. Tutte e tre propongono come elemento di mediazione tra la campagna ed il tessuto edificato il proprio grande giardino. La Alari Visconti e la Uboldo si espandono ben oltre il Naviglio; la prima, settecentesca, con un vasto prato delimitato da due quinte di pioppi neri nella varietà italica, altrimenti noti come pioppi cipressini, la seconda, neoclassica, con un cono prospettico aperto nel giardino piantumato. Similmente, la Villa Biancani Greppi, ortogonale a tutte le altre e posta a chiusura del paese, verso la campagna, si apriva un tempo ad oriente con una serie di prospettive alberate, connettendo la campagna ai poli estremi del complesso, di cui era pur partecipe la villa stessa. Un sistema articolato in cui volumi e spazi aperti gravitavano attorno al corso d’acqua in un continuum di grande rilievo architettonico, rafforzato dai giardini e dalle alberature spinte sino al naviglio.
Sul Naviglio Grande, del resto, il sistema di ville di Cassinetta di Lugagnano determina una propria influenza spaziale da un lato nelle controllate e contenute proporzioni dei cortili, dall’altro nel rapporto tra la villa e l’ambiente circostante attraverso le ampie dimensioni del giardino – la cui presenza va al di là del rapporto spaziale con l’edificio, per divenire il luogo del collegamento con il paesaggio agrario – allungando un asse prospettico verso la campagna.
Eccezionalmente qui lo spazio vuoto, il prato, il giardino, i campi divengono elementi essenziali nella configurazione architettonica delle ville. Così era alla Villa Birago, Clari Monzini davanti alla quale si allungava un cono prospettico assai ampio, il cosiddetto prato lungo 800 m, sino al naviglio. Tale lunghissima prospettiva che si allungava da est ad ovest era essa stessa architettura, costruita anche attraverso la ripetizione calcolata di pilastri binati – intercalati da un doppio filare alberato – sino alla conclusione dell’imbarcadero sull’acqua. Questi picchetti, due dei quali ancora in situ, materializzavano l’asse che strutturava l’impianto urbanistico, spingendosi con il proprio effetto sin oltre il naviglio, a quei quattro grandi platani della sponda opposta, punto di definizione e di tensione cui convergevano, con una lieve distorsione angolare, gli assi della Villa Negri. Diversamente dalle altre, l’impostazione di Villa Negri è data dalla successione giardino-villa-giardino, con il corso d’acqua che non è più elemento di confronto con la facciata ma, piuttosto, elemento di riferimento spaziale per la grande esedra all’ingresso, settecentesca. La stessa esedra aveva un ruolo determinante – ed in questo senso si può leggere l’arretramento della villa e della facciata – per il complesso, dato che costituisce a tutt’oggi l’anticipo solenne alla villa, tramite il primo giardino e, una volta, soprattutto, l’antitesi e la contrapposizione a quella lunghissima prospettiva del prato che costituiva il collegamento con la Villa Birago, Clari Monzini. Quello stesso asse che aveva il proprio trait-d’union con Villa Negri nei quattro maestosi platani che contraddistinguono ancora oggi il suo ingresso, così imponenti da suggestionare a tal punto da identificarsi con la villa stessa, conosciuta con l’appellativo I Platani (12).
Quando sostengo che l’albero è architettura non mi riferisco “solo” alla sua specifica natura di prodotto “della natura”. Già a questo punto l’analisi si può approfondire a tal punto da non lasciare dubbi in proposito, come se l’apporto ciclico della natura fosse dipendente da una volontà superiore, umana, per l’appunto. Che dire, per esempio, di certi soggetti che paiono assurgere a ruolo di “monumento”, se di monumenti si parla a proposito di alberi (13)? Monumenti come il Platano del Piccioni (Ascoli Piceno), il Cipresso di Villa Verucchio (Forlì) o il Leccio dell’Eremo delle carceri (Assisi). Il censimento del Corpo Forestale dello Stato ha espressamente ricercato negli alberi monumentali la loro specifica individualità di eccezione, per età o dimensione, per ruolo in un determinato luogo e momento storico. Dalla schedatura di circa 22.000 alberi di particolare interesse emergono 150 soggetti che presentano caratteri di eccezionalità in ordine a valore culturale e contenuto naturalistico.
Della selezione fanno parte il Castagno dei Cento Cavalli sito nel territorio di Sant’Alfio (Catania) ed un altro poco meno vasto, il Castagno della Nave, con circonferenza al tronco pari a 20 m, sito nel comune di Mascali, sempre in provincia di Catania.
Secondo il botanico Peyronal, il Castagno dei Cento Cavalli ha un’età stimabile tra 3000 e 4000 anni, ed è ritenuto l’albero più grande d’Italia ed il più antico d’Europa. Svetta sino ad oltre 50 m di altezza il Liriodendro del Parco Besana di Sirtori (Lecco), avvicinato da una sequoia del Parco Burcina di Pollone (Vercelli). Tre larici della Val d’Ultimo, nei pressi di San Geltrude (Bolzano) hanno un’età probabilmente superiore ai due millenni; di questi il più grosso ha circonferenza al tronco di 8,20 m. Un quarto esemplare fu sradicato da una bufera nel 1930; misurava 7,80 m di circonferenza e sulla enorme ceppaia furono contati 2200 anelli annuali.
L’immagine dell’albero rimanda istintivamente all’altezza, allo svettare delle forme, allungate ed affusolate, come colonne. La medesima sensazione di vertigine nell’osservare al piede i tronchi di una massa boscosa di larici mi coglie nell’osservazione delle colonne di una cattedrale gotica dall’interno delle sue navate allungate verso l’alto, ed i fasci di luce tagliano lo spazio come lame, filtrando come tra le chiome e le fronde. La cattedrale di Caspar David Friedrich non si innalza solo con le pietre che danno struttura al corpo centrale ma è un tutt’una con le sagome dei grandi abeti che la affiancano e, nella bruma infuocata del tramonto, le cime delle conifere diventano altrettante guglie della maestosa cattedrale che emerge tra le rocce (si veda, appunto, di Caspar David F., Croce e cattedrale sulle montagne, 1812 circa, nell’introduzione a Paesaggio e memoria di Simon Schama) (14).
Nella Caccia notturna di Paolo Uccello, 1470 circa (Oxford, Ashmolean Museum), è rappresentata una scena di caccia inserita in uno spazio molto scenografico. L’artista moltiplicò i dettagli in una smagliante composizione di colori, tra le figure umane ed animali che si stagliano sul cupo verde del bosco. La scena rappresentata è unitaria e lo spazio dilatato, scomposto in una serie di scorci prospettici autonomi nel fantastico sovrapporsi dei tanti tronchi d’albero, esili ed eretti come un fitto colonnato al di sotto della folta copertura delle chiome. Una selva di tronchi che assimilo alla selva di colonne della Yerebatan Sarayi-sarnici di Istanbul, la cisterna sotterranea costruita al tempo di Costantino I (306-337 d.C.) ed ampliata con Giustiniano (557-565); misura 141 m x 73, conta 336 colonne in pietra alte 8 m, ordinate su un modulo di 28 x 12 file.
Colonne come tronchi non solo ideali ma rappresentate alla stregua di alberi pietrificati nel Parco Güell (1900-1914) di Antoni Gaudì, a Barcellona: una selva di pilastri e sostegni dei percorsi sopraelevati e delle terrazze trattati come alberi secolari, espressivamente ricondotti alla matrice naturale con l’andamento diritto o piegato, con la superficie tormentata dalla corteccia profondamente incisa e con il verde vero che, nel tempo, si è espanso ed insinuato ovunque a fondersi con l’architettura e la pietra. Non casuale compenetrazione dovuta all’incessante opera del tempo ma ciò che Gaudì aveva previsto in questo esemplare luogo di architettura e natura.
Il dipinto Nel bosco (1855) di Asher Brown Durand, rappresenta un bosco di betulle con le cime inclinate le une verso le altre, a chiudere lo spazio come lungo una navata e Simon Schama vi intravede rieccheggiare una architettura gotica. Lodovico Meneghetti va oltre: nella Quercia in inverno (1829) di Caspar David F. – “la nuda forza architettonica della quale, come possente colonna, risalta” – identifica “un simbolo speciale”, indugia sull’albero “ovulo fecondato dall’intelligenza umana dall’Homo sapiens in poi”. Individua poi un piedritto nella rielaborazione della quercia di Caspar David F. proposta da Pericoli nel suo catalogo di alberi d’artista, quasi a sembianza di una scala a pioli con i rami ridotti a tormentati monconi (15).
Il legame degli alberi con i luoghi e le vicende storiche rappresentano un ulteriore elemento di interesse; in questo senso rappresenta un caposaldo il leccio di Assisi, l’albero francescano della predica degli uccelli dipinto da Giotto alla fine del XII secolo nella Basilica Superiore. Nella Sala decorata “alla Boschereccia”, Vincenzo Martinelli (1737-1807) e Giuseppe Valiani (1735-1807) realizzano una fra le più suggestive stanze-paese della Bologna napoleonica. Le pareti si aprono illusionisticamente su ampi giardini e panorami aperti, ricchi di alberi e vegetazione boscosa, in una complessa ripartizione di spazi che regolarizzano la natura secondo le tendenze del nuovo razionalismo classicista (16).
Enormi alberi divenuti al fine punto di riferimento per le comunità, un simbolo sociale cui ci si riferisce per convocare adunate ed assemblee di piazza, tanto più quanto maggiore è l’età dell’albero, quasi che fosse eterno e non riconducibile ad una dimensione temporale umana. Prato della Valle, a Padova, è una grande piazza delimitata da cortine di palazzetti sulla quale emerge Santa Giustina. Un tempo teatro di feste, di riti e adunate cittadine ancora oggi vi si svolgono fiere; fu sistemata al centro nel 1775 da Domenico Cerato con un giardino ovale, cinto da un ampio fossato ornato da una doppia serie di statue. Il boschetto interno è attraversato da quattro viali che si incontrano al centro dell’isolotto, una folta macchia verde che deriva dalla tradizione del giardino nobiliare, in questo caso votato totalmente all’uso pubblico e proposto come soluzione urbanistica che usa propriamente l’alberatura come compendio di un progetto complessivo di qualificazione ambientale.
Il paesaggio tanto celebrato in passato ed oggetto di attenzione particolare oggi – a fronte dei guasti perpetrati nella seconda metà del Novecento, soprattutto - non è stato generato da una idea paesaggistica o da una volontà di abbellimento (o non solo), ma da progettualità. Singolarmente osserviamo all’attribuzione di coscienza paesaggistica ad epoche che hanno visto prender forma e consolidarsi assetti territoriali, derivando quelle forme che oggi leggiamo in una infinita varietà di paesaggio, seppur non vi fosse stata al tempo alcuna intenzionalità o, perlomeno, il pensiero della proprietà del progetto del paesaggio fosse ancora di là da venire nella moderna e contemporanea accezione. Le montagne pulsanti di Goethe, il lucertolone filosofico di Heine, l’albero opera senza autore di Valery – che assomiglia molto agli Alberi di Mondrian, trasfigurati sino all’astrazione - suggellano che in definitiva la natura è pensiero e la forma del territorio è satura di progetto. Credo che anche per questo ogni opera progettuale debba oggi più che mai confrontarsi con il codice naturale del paesaggio (17).
Un presupposto alla questione ambientale, maggiormente nelle aree metropolitane e segnatamente in quella milanese dove il paesaggio agrario è cardine di un moderno progetto del territorio, per una nuova qualità degli spazi e della vita: “Il ribaltamento consiste nel restituire una visione, infine una realtà unitaria, entro la quale il paesaggio non edificato ma strutturalmente forte, in una situazione dell’ambiente drammatica perfino dal punto di vista del puro ciclo vitale dell’uomo, diventa, ora, il bene comune più importante per la collettività, salva, se così posso dire, la città, la metropoli” (18). Concretamente, propongo qui un’idea fortemente esemplificativa applicata ad alcuni casi concreti esaminati; a Bussero, est Milano, dove il registro del progetto è la trama fitta e regolare delle alberature che si addensano in tutti gli spazi liberi della città. L’albero è dunque elemento di architettura in grado di dare misura allo spazio e qualificare l’ambiente divenuto irriconoscibile.
A Lacchiarella, sud Milano, dove gli interventi edilizi degli ultimi anni hanno compromesso la porzione a nord del suo territorio, è possibile salvare e valorizzare la bellezza dell’antico borgo agricolo e dello straordinario paesaggio agrario al limite della provincia di Pavia, mediante un progetto caratterizzato da una fitta piantumazione a griglia che penetra nelle frange non progettate, ricostituendo una nuova qualità dell’insediamento umano e promuovendo in termini assoluti il disegno dell’antico borgo agricolo.
Homo erectus, come del resto è eretto l’albero. Tronco è la struttura portante dell’albero dal quale si dipartono i rami. Dalle palificazioni alle torri, il richiamo ad una matrice naturale dell’architettura è esplicita e all’albero fa spesso riferimento, sino a tradurre materialmente la sua natura in artificio; dall’uso dell’albero come rifugio, con un comportamento così diffuso in natura, all’impiego del legname come componente costruttivo, sino a divenire unico ed esclusivo in ambiti territoriali specifici. Le architetture medievali più significative dei paesi scandinavi sono le Stavkirker, chiese di legno, costruite in gran numero a partire dall’XI secolo, in seguito alla conversione della Norvegia al cristianesimo.
Fra le poche decine rimaste in Norvegia – erano circa 1300 – la più significativa è la Chiesa Lignea di Urnes, sulla costa atlantica, Contea di Hordaland. Prevale per datazione, architettura – tutto, dalle strutture portanti alle decorazioni, è in legno – e stato di conservazione.
Il tronco che diventa palo, piedritto, architrave ma che rivela la medesima funzione anche quando ha salde radici approfondite nel terreno. Una funzione anche simbolica quando la sua collocazione risponde a finalità che vanno al di là della intrinseca funzione naturale. Grossi platani inquadrano i due portali all’ingresso della Cascina Cònigo di Noviglio (Milano). La capezzagna che conduce alla corte della Cascina I Dossi di Brembio (Lodi) è segnata da un duplice filare di carpini; transitarvi in estate significa addentrarsi per oltre trecento metri in una oscura selva intricata di rami, una galleria che chiude completamente lo spazio al cielo. In un breve passo tratto da una guida del Tci, il territorio piemontese ad ovest del Po è descritto con efficace sintesi:”…lasciata alle spalle la periferia della grande conurbazione torinese, la vista spazia su di un paesaggio preminentemente rurale. A destra, su di uno sfondo dominato nelle giornate limpide, dalla schiera delle Alpi, si alternano colture cerealicole, prati, filari di pioppi. Rimangono, isolati o a piccoli gruppi, alberi legati all’antico assetto agrario e all’economia d’altri tempi: i gelsi (già connessi all’allevamento dei bachi da seta), i salici (usati per la confezione di cesti, gerle, manici di attrezzi, zoccoli), i noci (più sfruttati per l’olio, oltre che per il legno), i pioppi cipressini di notevoli dimensioni che appaiono spesso collocati in funzione di termini o agli ingressi dei viali che portano alle cascine” (19).
Nell’ambiente culturale germanico, dove è nata la silvicoltura moderna, fu dato corso all’idea, provocatoria ed avvincente, di realizzare un’opera letteraria sugli alberi che andasse ben oltre i consueti volumi di botanica, limitati alla sola illustrazione della tassonomia degli alberi. Quell’opera fu realizzata con la stessa materia che trattava; il volume dedicato al Fagus, il faggio europeo, ad esempio, era rilegato con la corteccia di faggio; semi, frutti e foglie si trovavano all’interno del libro e le pagine erano foglie letteralmente. Non mero divertissement entro il significato dello studio degli alberi ma, semmai, intelligente omaggio alla materia vegetale di cui è costituita tutta la produzione libraria (e la letteratura), una “stupefacente asserzione della necessaria unità tra cultura e natura” (20). I volumi della xiloteca, la biblioteca lignea, sono anche il prodotto dell’Illuminismo, quando indagine scientifica e sensibilità poetica si trovavano affiancate in una simbiosi perfetta.

|