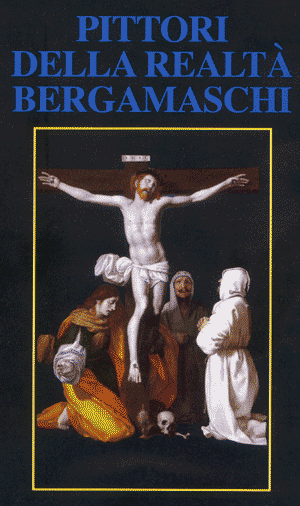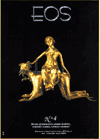|
Anno 2 - N. 5 / 2003
PITTORI DELLA REALTÀ BERGAMASCHI
Il dato della “provincia” come humus fertile per la nascita di un’arte attenta alla verità delle cose piuttosto che a un canone ideale di bellezza
di Elena Fumagalli
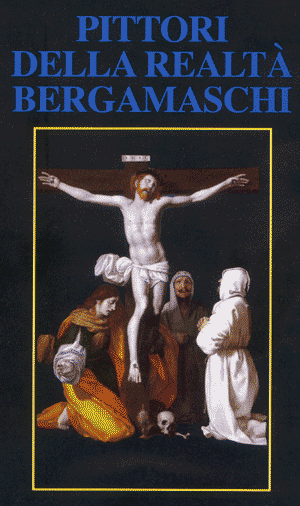
Crocefisso con la Maddalena
e i due Disciplini bianchi (1641)
Carlo Ceresa -
Mapello, Chiesa di San Michele
Con la definizione, densa di implicazioni, di “pittori della realtà in Lombardia” (titolo di una memorabile mostra allestita al Palazzo Reale di Milano nel 1953), Roberto Longhi portava alla conoscenza del grande pubblico il frutto di studi da lui iniziati decenni prima, individuando nell’ambito artistico bergamasco-bresciano una costante che collega lungo l’arco di tre secoli, dal Cinquecento al Settecento, le personalità di Giovan Battista Moroni (1520/24-1578), Giovan Paolo Cavagna (1550 ca.-1627), Carlo Ceresa (1609?-1679), Evaristo Baschenis (1617-1677), Fra’ Galgario (1655-1747), Giacomo Ceruti (1698-1767): tale costante si identifica in uno specifico carattere naturalistico, tradotto nel tono domestico e informale, antiaccademico, con cui sono trattati i soggetti, nell’attenzione, sul piano tecnico, per la resa degli effetti luministici e ottici, ottenuta spesso attraverso una stesura semplice e tinte pure, mezzi tesi, più in generale, ad una rappresentazione aderente al vero, nonché nella particolare predilezione per generi quali il ritratto e la natura morta (di cui il Baschenis, a metà Seicento, fu il vero protagonista, non senza cimentarsi anche nella ritrattistica).
Scegliendo la definizione di “pittori della realtà”, Longhi si ricollegava volutamente a una fortunata esposizione tenutasi a Parigi nel 1943, intitolata Les peintres de la réalité en France au XVIIe siècle, che aveva riunito artisti francesi del Seicento di varia estrazione naturalistica, direttamente caravaggesca e non. Origine comune di tale definizione (che andava a toccare un termine, quello di “realismo”, così complesso nella sua essenza) era la riscoperta dei peintres de la réalité seicenteschi operata a metà Ottocento da Champfleury, uno dei maggiori sostenitori di Gustave Courbet, protagonista, all’epoca, del movimento artistico denominato Realismo.
Il dato della “provincia” come humus fertile per la nascita di un’arte attenta alla verità delle cose piuttosto che a un canone ideale di bellezza avrebbe poi ispirato altre riflessioni critiche (riferite anche a una più vasta zona padana), alcune delle quali particolarmente sentite.
E’ il caso di Giovanni Testori – di cui ricorre quest’anno, non dimenticato, il decimo anniversario della scomparsa – che, scrivendo dei pittori sopra citati, ha saputo penetrare non solo dentro i loro dipinti, ma anche nell’anima di coloro che li commissionarono e li videro per la prima volta, nonché degli spettatori di oggi, quelli che, pur senza l’obbligo di condividere le forti scelte di vita e di spirito dell’autore, riconoscono nelle sue parole una parte di sé o, quanto meno, della propria storia.
Nel Cristo portacroce del Moroni (Albino, Santuario della Madonna del Pianto, 1560-65 circa), ad esempio, Testori coglie in modo mirabile l’essenza della religiosità popolare – verrebbe da dire “provinciale” – radicata nella bergamasca e così la traduce: “(…) quel Cristo, dicevo, porta la sua croce con l’umile e smorta consapevolezza di tutte le vittime e di tutti gli agnelli; e la porta vestito di quell’incredibile lanetta rosa-arancio, quasi che addobbandolo in quel modo gli albinesi volessero renderlo meno ‘risibile’; certo infinitamente onorarlo, infinitamente amarlo e riconoscerlo così loro unico e vero re.
C’è, ecco, da tremare; d’una fede, intendo, così usuale e radicata, così straziante e lucente, così raccolta e raccontata (…)” (1).
Rispetto all’isolamento dolente del Cristo del Moroni, la faccia dello stendardo processionale con San Rocco e i Disciplini verdi (Bergamo, chiesa di San Rocco, 1591) dipinto dal Cavagna per la confraternita di questi ultimi ben esemplifica la ricerca della “realtà” attraverso sorprendenti effetti luministici: le ombre proiettate sul pavimento e sulla base della nicchia entro cui è il santo (quasi una statua vivente, di dimensioni maggiori delle altre figure), nonché quella della sua sagoma sul fondo, raggiungono un effetto di grande verità, mentre i volti dei confratelli inginocchiati ai due lati paiono ciascuno un ritratto.
Così, infatti, scriveva Longhi nel 1953: “(…) è più significativo che il Cavagna, il più antico fra i pittori locali dopo il Moroni (…), venga a toccar effetti non tanto lontani da quelli del Caravaggio giovine (…) il meglio di questi tentativi del Cavagna è in ambito ritrattistico (…) tanto che persino nelle sue pale d’altare, basta, per circoscrivere il meglio, isolare i brani dove intervengono ritratti” (2).
Un’intensa forza luministica e cromatica emana il Crocifisso con la Maddalena e due Disciplini bianchi del Ceresa (Mapello, chiesa di San Michele, 1641), come compresso entro la tela, senza lasciare margini di spazio.
Svincolata dai retaggi post-tridentini di cui ancora risentiva il Cavagna, l’immagine si apre a una luminosità dirompente, soprattutto nel contrasto (che non a caso ha richiamato il nome di Zurbáran) fra il candore dei bianchi e lo scuro delle nuvole sullo sfondo, un nero squarciato solo in corrispondenza dell’apertura delle braccia del Cristo da un azzurro carico. Ai colori sgargianti di cui è abbigliata la Maddalena si contrappone il bianco del confratello che le sta di fronte, a dire il vero quasi solo una tunica , da cui sporgono le mani giunte e un accenno di profilo nascosto dal cappuccio, mentre del suo compagno, rivolto di fronte allo spettatore alle spalle del Crocifisso, che appare vestito di grigio per contrasto tonale col nero del fondo, si coglie l’espressione pentita e il pugno che batte il petto.
La stessa intensità che, sia pur con accenti diversi, trapela dai soggetti religiosi dipinti dagli artisti citati, caratterizza anche i ritratti, in cui la presa diretta dal naturale segna il distacco rispetto ai quadri sacri.
La Donna in nero del Moroni (Bergamo, Palazzo Moroni, 1570 circa) è un’opera del periodo maturo del pittore, che adotta qui il taglio di tre quarti a lui caro sia per la figura che per la posa. Seduta su una savonarola (come altri suoi effigiati) contro uno sfondo appena rischiarato rispetto al nero della veste, la donna tiene un paio di guanti nella mano sinistra e un breviario con la destra, il cui indice è infilato tra le pagine (anche questo un particolare ricorrente nella ritrattistica moroniana). Tale mano fu realizzata dopo che il libro era già stato eseguito, sovrapponendosi alla sua superficie più scura, e ciò la dice lunga sul metodo di lavoro del Moroni, soprattutto nella rappresentazione delle mani, di norma non disegnate ma dipinte con grande libertà, quella stessa libertà che, in questa tela, si nota nello scorcio imperfetto del braccio destro, risolto secondo la visione ottica privilegiata dall’autore, che coinvolge come mezzo di indagine anche la luce. Nel potente realismo del volto, nell’espressione di tono medio e non idealizzante, nei valori umani che comunica, c’è tutta l’essenza della ritrattistica moroniana.
Forti affinità rispetto a questa visione si riscontrano anche nel Ceresa: nel Ritratto di Laura Zignoni Boselli (collezione privata, 1640) una lunga iscrizione in alto a sinistra, apposta dopo la morte della donna, ne celebra le qualità morali (“religione prudentia. / morum integritate. / omnique virtute insignis. / vixit”), che sembrano riflettersi nel suo viso, a cui ben si addice l’espressione, ancora una volta del Testori, di “premanzoniana umiltà”) (3). Di nuovo la luce – benché altra rispetto a quella del Moroni, ora sulla scia del naturalismo post caravaggesco – indaga il volto della donna, parzialmente in ombra, delinea le mani, come anche le pieghe dell’ampio grembiule. Così Longhi coglieva, nel 1953, questo aspetto della ritrattistica del Ceresa: “(…) la sua cura nel concretarli [i modelli] quasi ossessivamente come ‘oggetti’ fra luci e ombre a contrasto è assai simile alla lunga pazienza con cui Evaristo Baschenis (…) colloca le sue miscellanee di oggetti al traguardo dell’immobilità (…) Potrebbe quasi dirsi (…) che il Ceresa dipinge i suoi ritratti come ‘nature morte’ a carica vitale, e il Baschenis le sue ‘miscellanee’ come ‘ritratti di strumenti musicali’ (…)” (4).
A chiudere questa serie di immagini femminili è il Ritratto di dama in nero (collezione privata, 1725-30 circa) di Fra’ Galgario (al secolo Vittore Ghislandi), vero specialista del genere. Con grande libertà pittorica egli ha dipinto il copricapo della donna, costruito a colpi di pennello e di luce, che si differenzia così dall’abito di uguale colore, di cui avvertiamo la pesantezza (e, insieme, quella del corpo che nasconde).
La posa “impostata”, lievemente vezzosa, della dama, che con la destra tiene un lembo del copricapo, mentre la sinistra appoggia sull’anca, svelando un avambraccio un po’ tozzo, si accompagna magistralmente all’espressione del volto, a cui l’impercettibile curva delle labbra a destra verso l’alto e le palpebre di poco abbassate imprimono un tono fintamente altezzoso, che ancora al Testori ha fatto immaginare di “vedere prefigurata qualcuna delle portiane Damm del Bescottin, ovvero e addirittura la Marchesa Cangiasa o la Donna Fabia Fabron de Fabian nell’atto di prepararsi ad entrare in Sant Cels” (5).
San Rocco e
i Disciplini verdi (1591)
Giovan Paolo Cavagna -
Bergamo, Chiesa si San Rocco
Cristo portacroce 81560 - 65)
Giovan Battista Moroni -
Albino, Santuario della Madonna del pianto
Ritratto di donna in nero (1570 c.)
Giovan Battista Moroni -
Bergamo, Palazzo Moroni
Ritratto di Laura Zignomi Boselli (1640)
Carlo Ceresa -
Collezione privata
Ritratto di donna in nero (1725 - 30)
Fra' Galgario -
Collezione privata

|